Gli Amici della domenica, il gruppo storico della giuria del premio, hanno segnalato cinquantasette libri di narrativa in lingua italiana pubblicati tra il 1 marzo 2018 e il 28 febbraio di quest’anno.
Spetta ora al Comitato del premio – composto da Pietro Abate, Valeria Della Valle, Giuseppe D’Avino, Ernesto Ferrero, Simonetta Fiori, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine – scegliere i 12 titoli che si disputeranno l’edizione 2019, sia tenendo conto delle proposte degli Amici, sia sulla base di valutazioni proprie, che potranno eventualmente integrare la lista iniziale.
I 12 libri candidati saranno annunciati domenica 17 marzo alle ore 12.30, in una conferenza stampa che avrà luogo a Roma, nella Sala Ospiti dell’Auditorium Parco della Musica, durante Libri come. Festa de Libro e della Lettura.
Interverranno Giuseppe D’Avino, Presidente di Strega Alberti Benevento, Valeria Della Valle, Presidente del Comitato scientifico della Fondazione Bellonci, Melania G. Mazzucco, Presidente del Comitato direttivo del Premio Strega, Giovanni Solimine, Presidente della Fondazione Bellonci. Coordinerà l’incontro Stefano Petrocchi, Direttore della Fondazione Bellonci.
L’immagine che accompagnerà la LXXIII edizione del Premio Strega è stata realizzata da Alessandro Baronciani, che si è ispirato all’illustrazione della storica urna di voto dipinta da Mino Maccari,
riprendendone anche lo slogan: “Se la Strega ha una scopa, la
Letteratura deve avere uno scopo.” La scopriremo insieme il 17 marzo a Libri come.
Ecco l’elenco dei cinquantasette libri proposti:
Carmine Abate, Le rughe del sorriso, Mondadori – proposto da Antonio Pennacchi;
«Romanzo d’amore e di migrazioni, Le rughe del sorriso di Carmine Abate è
la tormentata storia di una ragazza somala, costretta ad abbandonare il
suo paese dalla violenza interna che lo devasta; tra mille peripezie
attraverserà l’Africa ed il Mediterraneo per approdare infine, non tanto
tranquillamente, in Italia. È un libro non soltanto bello, ma
assolutamente necessario in questa fase per ricordare al nostro, di
Paese, le sue dirette responsabilità coloniali e postcoloniali nelle
lacerazioni esplose così drammaticamente in questi anni in Somalia e
larga parte dell’Africa tutta.»
Emanuela E. Abbadessa, È da lì che viene la luce, Piemme – proposto da Rosellina Archinto;
«Il romanzo è sostenuto ,per così dire, da una scrittura “febbrile”.
Molta Sicilia, selvaggia, piena di sole, grondante di miti. Personaggi
tra Verga e Brancati. Alla figura del Barone (in realtà il fotografo Von
Gloden), ai suoi sentimenti delicati e rarefatti, fanno da contrasto
l’energia selvatica di Agata, i rossori di Sebastiano, il non detto di
Elena Amato (straordinaria figura femminile). Il rapporto quasi
simmetrico tra quest’ultima e il Barone è una storia nella storia. Il
fascismo descritto in tutte le sue anime contraddittorie (Alfio e
Alfredo Romano) fa da sfondo temporale, ed è ancora un’eco lontana. La
non dichiarata omosessualità del Barone, tiene insieme tutte queste
vite, le avvolge con delicatezza febbrile. Su tutto domina la magia
della fotografia: Fermo! quasi un grido.
Il cupio dissolvi finale, diventa quasi una liberazione. Un romanzo in qualche modo corale, musicale ma con il contrappunto di una tragedia i cui protagonisti si avviano al proprio destino ognuno per un percorso personale. L’unico, forse ,preservato Salvatore Caruso. La scrittura è, per così dire, ora densa, ora si stempera in descrizioni che sanno trasmetterci i profumi, le sensazioni più rarefatte della Sicilia.»
Il cupio dissolvi finale, diventa quasi una liberazione. Un romanzo in qualche modo corale, musicale ma con il contrappunto di una tragedia i cui protagonisti si avviano al proprio destino ognuno per un percorso personale. L’unico, forse ,preservato Salvatore Caruso. La scrittura è, per così dire, ora densa, ora si stempera in descrizioni che sanno trasmetterci i profumi, le sensazioni più rarefatte della Sicilia.»
Valerio Aiolli, Nero ananas, Voland – proposto da Luca Formenton;
«Nero Ananas di Valerio Aiolli ricostruisce gli eventi drammatici
che hanno segnato la storia d’Italia nei cinque anni che vanno dalla
strage di piazza Fontana del12 dicembre 1969 alla strage della Questura
di Milano del 17 maggio 1973, ricostruendone i fatti attraverso un
racconto polifonico e orizzontale, e un ritmo cronologico che accompagna
il lettore, giorno per giorno, mese per mese, allo straziante epilogo
di via Fatebenefratelli. Verosimiglianza e realtà si confondono in
quest’opera, che ha il merito di essere riuscita in un’impresa senza
dubbio difficile: restituire quel periodo della nostra coscienza
culturale e storica senza cedere alla pura mediazione della cronaca, ma
mettendo in scena una narrazione corale, universale – a volte
intimamente vertiginosa –, e capace di raccogliere in queste pagine una
moltitudine policroma di voci, spesso antagoniste tra loro. Storie e
ricordi dal colore familiare si mescolano infatti, in Ananas nero,
a quelle di personaggi, come il Dottore, Falstaff, Zio Otto, il Samurai
e il Pio, dietro ai quali si possono facilmente riconoscere i
protagonisti di quegli anni – senza mai però risultare specchi di se
stessi, ma incarnando profondamente lo spirito, contraddittorio ed
elusivo, del loro tempo. Così, accanto a estremisti di destra che si
incontrano e tramano di nascosto, anarchici in cerca di riscatto e
agenti dei servizi segreti che osservano tutto nell’ombra, compaiono
vite quotidiane, famiglie che si riuniscono intorno alla tv per capire
cosa stia succedendo, parenti scomparsi e storie di amore e di odio
consumate nell’intimità di biografie minori. Per farlo, Aiolli si affida
a una scala di colori stilistica di assoluta qualità, che permette
all’autore di muoversi tra i differenti timbri espressivi cogliendone i
particolari e le sfumature, pur mantenendo nell’insieme una tonalità
letteraria ordinata e coerente. Più del regesto storico (che ad ogni
modo viene accolto tra le righe e meticolosamente affrontato nella
sezione che chiude il volume, Futuro anteriore), ciò che
interessa ad Aiolli è il gesto invisibile, l’incontro nascosto, il
combattimento interiore di chi ha vissuto sulla propria pelle i fatti
drammatici, e l’esplosione sentimentale che ha fatto da eco a quella
degli ordigni terroristici. Fin dalle prime pagine, è sempre presente la
sensazione che il rumore cieco della bomba in piazza Fontana abbia
causato molti più danni di quanti, già tragicamente ingenti, la scena
poteva restituire: ha sgretolato l’innocenza di un paese, ha aperto una
voragine nelle coscienze di cui è impossibile valutare la profondità e
l’estensione, e segnato senza possibilità di ritorno gli anni a venire,
quelli della “strategia della tensione”. Uno dei principali meriti di
Aiolli, in questa suo romanzo, è allora quello di aver riportato a galla
non solo il ricordo o la memoria delle tragedie, ma il fiato, le
parole, il dolore, gli epitaffi di coloro che, protagonisti, vittime o
semplicemente lontani spettatori, hanno vissuto sul limitare di quel
precipizio, grigio e nebbioso, chiamato Italia.»
Emanuele Altissimo, Luce rubata al giorno, Bompiani – proposto da Roberto Ippolito;
«Le parole sono quelle giuste, non una di più. Le frasi sono pulite, ma
idonee per trasmettere una forte intensità emotiva. La scrittura di
Emanuele Altissimo, contemporaneamente agile e sostanziosa, fa scivolare
il lettore tra il dolore e la follia, tra la capacità di affrontare la
vita e l’incapacità dei protagonisti di “Luce rubata al giorno” di darle
un senso. Il punto di partenza della sofferenza e quindi del racconto è
subito chiaro: il doppio lutto di due fratelli di 13 e 21 anni, che
hanno perso il padre e la madre in un incidente stradale e vivono con il
nonno. Eppure non si sa mai cosa sta per accadere ovvero dove l’autore
sta portando. Né ci si accorge che dietro la storia c’è l’autore, che
firma la sua opera prima rivelatrice di un talento narrativo senza
dubbio meritevole.»
Gianluca Barbera, Magellano, Castelvecchi Editore – proposto da Arnaldo Colasanti;
«Magellano di Gianluca Barbera è una vera sorpresa nel panorama
della letteratura italiana contemporanea. Nelle forme apparenti del
romanzo storico, è di fatto un libro incessante di avventure e di
scoperte, con un gusto libero per il romanzesco e una intensità
narrativa che, a tratti, ha dello strabiliante. I dati storici che
innervano il testo costruiscono i personaggi, gli ambienti, le
psicologie in gioco. Le pagine si arricchiscono di un’orchestrazione
ritmica da grande epos: il genere del “romanzo storico” resta un’ombra
tra le quinte, mentre la forza del racconto conquista la bellezza
immemorabile di alcuni personaggi, in primis il protagonista. La
maggiore virtù di Barbera è rendere la storia un caleidoscopio di
emozioni, usando una scrittura scaltra e veloce, senza cedere nulla alla
digressione.»
Federico Bonadonna, Hostia, Round Robin – proposto da Maria Rosa Cutrufelli;
«Il romanzo di Federico Bonadonna, Hostia, racconta una Roma
nascosta e spesso sconosciuta agli stessi romani, la sua periferia bella
nonostante il degrado, la sua umanità sofferente. Lo fa con accenti a
volte pasoliniani e usando in molte pagine un dialetto rude e colorito,
mai però di maniera. Al centro del racconto c’è una bambina con la sua
infanzia difficile, descritta con delicato realismo e profonda empatia.
La conosciamo a poco a poco, soprattutto attraverso le parole dello
psicologo che la cura. E che a sua volta ha bisogno di cure… Il romanzo
di Bonadonna ruota attorno a storie di famiglie complicate, storie che
s’intrecciano e si rispecchiano l’una nell’altra, pur mantenendo la loro
diversità. Ci sono misteri, in queste storie. C’è un tocco di “noir”
che prende il lettore o la lettrice: cosa c’è dietro il comportamento
aggressivo della bambina? E cosa c’entra la politica con questa creatura
infelice e marginale? Interrogativi che tengono con il fiato sospeso.
Ma il vero fascino del romanzo sta nella descrizione della sofferenza
intima dei personaggi, nell’analisi dei loro impulsi, nel racconto del
loro modo di vivere e della società che li accoglie o li rifiuta. Un
romanzo psicologico e al tempo stesso sociale.»
Raffaele Bussi, Ulisse e il cappellaio cieco, Armando Editore – proposto da Antonio Augenti;
«Ulisse, dopo il ritorno a Itaca, per sfuggire a quella che oramai è
diventata una vita piatta e priva di stimoli che lo portino a nuove
conoscenze, accetta l’invito, se non l’ordine, dell’Olimpo di rimettersi
in mare per una nuova avventura. La missione riguarda la ricerca delle
cause che da decenni affliggono le terre del Vecchio Continente.
Minerva, corsa in aiuto del suo protetto, per assicurare buon esito
all’impresa, gli affida quale compagno di viaggio, un tale Varoufakis,
venditore di cappelli, con l’emporio sul porto di Itaca. Cieco dalla
nascita, il vecchio magicamente riacquista la vista grazie ad un
berretto frigio che, indossato, gli consente non solo di leggere eventi
del passato, ma di scontare anche il futuro, potendo contare del dono
visionario dei profeti. Per portare a termine la ricerca, il re di Itaca
deve sciogliere un enigma iniziale: l’approdo a tre città nuove.
Neapolis sarà la prima, Cartagine la seconda, mentre l’indizio per
scoprire la terza lo suggerisce Didone. Una narrazione surreale, dove
Ulisse e il cappellaio incrociano personaggi dell’antichità, mentre
riscoprono mali della contemporaneità, dalle migrazioni incontrollate
con la perdita di vite umane nel Mediterraneo a causa delle guerre
ancora in atto, a terreni ridotti a sversatoi immondi d’ogni sorta di
putridume, fino al Grande mare, specchio d’acqua non più capace di
riflettere trasparenze. Il terzo approdo è al di là delle colonne
d’Ercole, suggerisce Didone su indicazioni del suo ammiragliato, una
nuova terra dove ricercare la terza e ultima città nuova, non “la città
promessa”, come suggerisce Varoufakis, “ma l’ignoto”. Ne risulta una
scenografia surreale che richiama magistralmente la moderna
cinematografia, nella quale spuntano persuasivi elementi che immettono
la straordinaria novità del romanzo nella realtà dell’attuale divenire
civile. Una narrazione intrigante e suggestiva che invita il lettore a
riflettere sulla contemporaneità.»
Giulia Caminito, Un giorno verrà, Bompiani – proposto da Gioacchino De Chirico;
«Un giorno verrà racconta di un piccolo paese, di una famiglia,
di alcune persone che si dibattono tra l’ingiustizia della loro
esistenza e la voglia di riscatto. Per costruire il contesto, l’autrice
sceglie una via non facile. Decide di posare lo sguardo su un numero non
indifferente di personaggi, sulle diverse attività lavorative, sulle differenti dimore del paese. Vi troviamo il panificatore, i contadini, i ciabattini, gli
animali, le case dei ricchi e quelle dei poveri. Troviamo i bordelli e i
posti di polizia, troviamo le chiese, i cimiteri e i conventi. Troviamo
inoltre la natura, come era logico che fosse in quei luoghi ricchi ma abitati da poveri, in un periodo in cui il possesso della terra era ancora elemento di esercizio del potere. Tre figure attraversano quei luoghi e entrano in relazione con i personaggi. Sono Lupo, Nella e Nicola. Lupo, bambino nudo e sporco che appena nato piangeva
sempre. Nicola, poca energia, bambino silenzioso quasi trasparente,
ragazzo di mollica. Nella, giovane bellezza rinascimentale, schietta,
morbida, dalla voce sgraziata e dialettale. Tre fanciulli, tre
adolescenti, tre esseri umani adulti. La vita di tutti si muove intorno a
due “monumenti” due “fari” e punti di riferimento, immobili nella loro
solennità eppure così capaci di azione. Sono Giuseppe, anziano anarchico
rispettato e ascoltato non solo dai Ceresa, la propria famiglia in cui
è nonno, e suor Clara, una donna nera, a dispetto del nome, misteriosa,
forte di carattere, fino a trovare seguito nella sua disobbedienza alla
gerarchia ecclesiastica e autorevole fino a essere capace di guidare
molto più di un convento ma, per certi aspetti, un intero paese. La capacità di
Giulia Caminito è nel sapersi muovere seguendo sempre un filo chiaro:
quello che divide i giusti dagli ingiusti, i poveri dai ricchi, i
diseredati dai padroni, gli sfruttati dagli sfruttatori, il potere
maschile dalla vita delle donne. Tutti devo lottare, chi per
sopravvivere, chi per emanciparsi , chi perché vuole un futuro migliore e
sogna un mondo più giusto. Queste anime dolenti e combattenti incontrano
la Storia: i moti della Settimana Rossa, l’avvento del Socialismo, la
Prima Guerra Mondiale, l’epidemia dell’influenza spagnola fino agli anni
bui del Fascismo. Ma i legami tra gli esseri umani sono quelli che
concludono questa narrazione in pagine spesso commoventi che oltre al
senso della storia ci restituiscono il senso profondo della vita.»
Giulio Cavalli, Carnaio, Fandango Libri – proposto da Concita De Gregorio;

«Giulio Cavalli in Carnaio racconta la storia di un piccolo paese
affacciato sul mare, DF, dove d’un tratto cominciano a essere sputati
dalle onde corpi senza vita di uomini tutti uguali. Come dice Giovanni
Ventimiglia, il pescatore che per primo si imbatte in uno di loro: «Se
galleggi, sei morto o sei una cosa, nel mare». Nessuno sa da dove
vengano, i cadaveri che arrivano a DF (Distretto Federale, potreste
pensare se conoscete l’America Latina). Nessuno in realtà ha intenzione
di scoprirlo: vorrebbero solo che sparissero, che ritornassero a
inabissarsi lasciando intonse le loro strade e le loro vite. Questo fino
al giorno in cui un’onda di carne e vestiti non intasa le vie,
sorprende le persone a passeggio e le travolge: il problema dei cadaveri
richiede ora un intervento. Ci vuole un’idea, una soluzione. Eccola: i
corpi da persone diventano cose e le cose possono essere trattate come
oggetti. A DF tutto cambia, i cadaveri da problema si trasformano in
materia prima, l’economia: della città si converte e si indirizza a
trarre profitto da quello che hanno da offrire: la carne e la pelle. In
un mondo distopico, immaginario eppure più vero del reale il libro di
Giulio Cavalli racconta il nostro paese. Una denuncia letteraria scritta
magistralmente, un ritratto inclemente del mondo che stiamo costruendo:
il racconto di una comunità che si organizza per far fruttare la
sventura, il termometro sociale e politico del tempo che viviamo.
Potremmo diventare, siamo già diventati DF: il paese chiuso, appestato,
impenetrabile dove gli abitanti si arricchiscono e blindano il segreto
inconfessabile della loro ricchezza mentre sono, nel tripudio del
cinismo, destinati all’estinzione. «Ai soccorsi, arrivati con poca
voglia di soccorrere, DF si presentò come una palla di vetro con neve,
quelle dei mercatini dove gli ambulanti portano guanti tagliati sulle
dita. Le palle di vetro provocano la felicità più meravigliosa e più
breve che si possa provare in natura, il tempo di uno scrollo, i più
resistenti ne fanno due, e poi finiscono nel comò per almeno tutta una
generazione, vengono ritrovate quando sono morti da un pezzo sia gli
acquirenti che gli ambulanti e un bambino la scrolla di nuovo, una
volta, massimo due. DF era cosi. Senza scrollo. Con le mosche al posto
della neve.»
Cristiano Cavina, Ottanta rose mezz’ora, Marcos y Marcos – proposto da Franco Buffoni;
«Ben scritto e magistralmente articolato in 42 brevi capitoli, il
romanzo sviluppa una tematica amorosa moderna e intrigante, avvalendosi
di una serie di piccoli colpi di scena e rovesciamenti di prospettiva,
che ne rendono particolarmente avvincente la lettura.»
Paola Cereda, Quella metà di noi, Giulio Perrone Editore – proposto da Elisabetta Mondello;
«Quella metà di noi è un romanzo intenso e coinvolgente,
ambientato nella Torino dei nostri giorni, in cui si muovono una folla
di personaggi a cui Paola Cereda affida il compito di narrare le
contraddizioni e le difficoltà della condizione contemporanea. La storia
centrale è quella di Matilda, una maestra in pensione, che per ripagare
un debito ricomincia a lavorare prendendosi cura di un anziano. Tutti e
tutto la condizionano: le passate esperienze, i familiari, la
situazione lavorativa. Lo spostarsi dalla periferia al centro di Torino,
la nuova solitudine e le inedite complicità. Il romanzo, sostenuto da
una lingua precisa ed essenziale, pagina dopo pagina diviene la
narrazione della condizione liminare che, in alcune fasi della vita,
tutti dobbiamo affrontare e interroga il lettore sulla possibilità di
non restare sulla soglia ma di diventare capace di immaginare, scegliere
e progettare il futuro.»
Paolo Ciampi, L’ambasciatore delle foreste, Arkadia editore – proposto da Antonio Riccardi;
«Nelle pagine di questo romanzo si ritrovano i temi più importanti della
nostra esistenza: l’amore per la natura, il bisogno di ricercare se
stessi, la capacità di intuire che il rapporto tra gli uomini deve
essere ricondotto su un piano meno alienante. L’ambasciatore delle foreste è un romanzo particolare, una sorta di biografia ante litteram,
che ripercorre le vicende di George Perkins Marsh, il padre
dell’ecologia moderna, poco conosciuto dalle nostre parti e notissimo
negli Stati Uniti, dove è considerato il “mentore” dei parchi nazionali,
soprattutto quello di Yellowstone. Grazie alla sua storia ci viene
regalata una visione nuova e sopraffina del problema ambientale, già
elaborato da un uomo vissuto in pieno XIX secolo, così lungimirante da
comprendere che solo il rispetto per la natura può permettere alla
civiltà di progredire con armonia. Dalle foreste del New England a
quelle dell’Appennino, dai deserti dell’Africa ai ghiacciai
dell’Islanda, il percorso di George Perkins Marsh, conduce il lettore
nell’intimo del rapporto con tutto ciò che la natura ha creato e messo a
disposizione degli uomini, affinché sia preservata e consegnata ai
posteri. Nelle pagine di Paolo Ciampi si percorre una vicenda umana di
grandissimo spessore, in cui il protagonista muove i suoi passi alla
ricerca di una sintesi tra progresso tecnologico e rispetto
dell’ambiente. Un romanzo che, pur calato nell’Ottocento, è attualissimo
e pone problemi e domande cui ancora oggi si stenta a dare adeguate
risposte.»
Benedetta Cibrario, Il rumore del mondo, Mondadori – proposto da Giorgio Ficara;
«Fondato su minuziosi studi d’archivio e sostenuto da una verve
narrativa personalissima, il lavoro di Benedetta Cibrario ci mostra un
punto di vista non convenzionale sul Risorgimento: Anne Bacon, inglese
malinconica e operosa in un piccolo Piemonte aristocratico, è un
personaggio originale in grado di registrare e testimoniare, giorno dopo
giorno, ogni impulso di una straordinaria evoluzione storica nel cuore
stesso di un mondo arcaico i cui segreti non risultano tuttavia, per
nessun aspetto, meno preziosi.»
Stefano Corbetta, sonno bianco, Edizioni HACCA – proposto da Ilaria Catastini;
«Il romanzo narra la storia di due gemelle, Emma e Bianca e della loro
famiglia, annientata dall’incidente che rinchiude Bianca per anni in un
sonno “bianco”, per l’appunto, il colore asettico dell’ospedale e quello
lattiginoso della nebbia che avvolge chi è intrappolato in uno stato
vegetativo. Emma, rimasta zoppa in quell’incidente, porta su di sé il
senso di colpa per quanto è accaduto alla sorella, reso ancora più grave
dalla silenziosa accusa che la madre non è capace di nascondere, né a
lei, né al marito e neanche a se stessa. Una madre mutilata
interiormente, che non riesce ad uscire dal quel vuoto che il dolore le
ha scavato dentro; un personaggio che l’autore disegna in modo genuino,
riuscendo a suscitare comprensione e perdono. Il padre fatica a tenere
insieme l’equilibrio familiare, scandito dalle visite in ospedale, nel
silenzio di una comunicazione impossibile; resiste al dilaniarsi del
rapporto con la moglie e si sforza di rappresentare un’ancora per Emma,
di cui percepisce la sofferenza, sempre più chiusa, sempre più estranea
all’ambiente famigliare. Una figura, quella del padre, delineata in modo
delicato, tenero ed efficace. Emma, privata della sua adolescenza, vive
costretta in un ruolo di controfigura del “fantasma” della sorella, che
cerca di imitare nella passione per il teatro, combattendo contro il
suo senso di inferiorità, schiacciata da quella ingombrante
assenza-presenza. In questo senso Corbetta affronta il tema del “doppio”
in modo efficace e originale. Tuttavia Emma è una ragazza tenace e
determinata, vitale (e qui l’autore riesce a restituire un personaggio
commovente), che trova nel teatro e nella musica il luogo dove
ascoltarsi e riconoscersi. L’elemento di novità del libro è però dato
dalla scoperta della possibilità che Bianca abbia una coscienza
“vigile”, dunque che possa sentire, percepire qualcosa dell’ambiente che
la circonda. Una condizione che la scienza sta realmente indagando e
che apre un capitolo completamente nuovo nella ricerca scientifica,
rivelando come l’assenza di reazione fisica e neurologica agli stimoli
possa non significare necessariamente una mancanza totale di attività
cerebrale. Il nostro paese è oggi all’avanguardia nel campo della
ricerca della coscienza, e Corbetta mette in luce un aspetto poco noto e
sicuramente degno di attenzione. Lo svelamento progressivo dello stato
in cui versa Bianca è frutto di studio e confronto con il Nucleo Stati
Vegetativi dell’Istituto Palazzolo di Milano. Il romanzo offre quindi
uno sguardo nuovo su questo ambito, che tocca molte persone, molte
famiglie, costituendo un elemento di novità nella conoscenza. L’autore,
al secondo romanzo, si misura con una scrittura essenziale, precisa e
controllata, rarefatta, solo apparentemente semplice, uno sguardo
fotografico in cui lo spazio bianco assume precise funzioni narrative e
dove il silenzio chiama il lettore a riempire gli interstizi della
storia. Il libro sta riscuotendo molti consensi, sia dalla critica che
dai lettori.»
Mauro Corona, Nel muro, Mondadori – proposto da Aldo Cazzullo;
«Propongo di candidare al Premio Strega 2019 il romanzo di Mauro Corona Nel muro
(Mondadori). Perché, nonostante i tentativi – cui lui talora collabora
volentieri – di trasformare Mauro Corona in macchietta, questo libro
conferma che aveva ragione Claudio Magris, che già vent’anni fa disse di
lui: «È nato uno scrittore vero.»
Alessandra Cotoloni, Il diario di pietra, Edizioni Il Papavero – proposto da Piero Mastroberardino;
«Si tratta di un romanzo storico dalle venature socio-antropologiche.
Protagonista è Fernando Nannetti, che incise la sua storia su 180 metri
lineari di muro nel corso della sua permanenza nel manicomio di
Volterra. Il racconto è anche romanzo dell’anima: la scrittrice mostra
l’uomo oltre le apparenze, al di là di etichette e della stessa
malattia. A parlare è quel muro, che trasuda le intime sofferenze di
persone escluse dalle proprie comunità familiari e sociali, nonché le
violenze a cui i pazienti spesso erano sottoposti, torture che li
tramutavano in fantasmi. La narrazione è guidata dal messaggio
principale di cui il protagonista è esclusivo depositario: la sequenza
delle comunicazioni trasmessegli da alieni che, dopo averlo nominato
“colonnello astrale”, complice la colonna vertebrale che fungeva da tubo
catodico, gli trasferivano eleggendolo a vettore connettivo di mondi
lontani. Il dibattito si apre proprio laddove la storia del Nannetti
apparentemente si conclude: quarant’anni dopo la legge Basaglia, ancora
siamo alla ricerca di una soluzione ad un problema tuttora vivo nelle
nostre comunità.»
Vittorio Cotronei, Passato remoto, MdS Editore – proposto da Paolo Ferruzzi;
«Conoscevo questo autore grazie al suo romanzo precedente Andalù
di cui avevo scritto la postfazione apprezzandone le intuizioni e la
descrizione con leggerezza quasi “kunderiana” di una cittadina
rivierasca ormai spoglia dei fuochi d’artificio estivi. In Passato remoto
c’è una maggiore consapevolezza; una trama densa ben congegnata e una
importante maturazione stilistica. Come l’opera precedente, anche Passato remoto
sfugge a una stretta collocazione di genere raggiungendo un felice
equilibrio fra l’affresco sociale di una provincia e di chi la abita
raccontati con rapide e vivide pennellate e una matrice di stampo
giallistico sospesa fra suggestioni di fantascienza e un affascinante
viaggio nei meandri della misteriosa civiltà etrusca. Una storia che si
snoda in tanti cunicoli aprendo via via la vista su camere segrete che
offrono al lettore un punto di vista ogni volta diverso su una vicenda
che rivela uno dopo l’altro i suoi molti segreti come un antico sepolcro
per la prima volta violato.»
Roberto Cotroneo, Niente di personale, La nave di Teseo – proposto da Dacia Maraini;
«Niente di personale di Roberto Cotroneo è romanzo intenso e
risoluto, scritto in un italiano nitido ed elegante e con una struttura
narrativa ostinatamente fuori dalle regole, che prova a dare risposte
allo smarrimento che stiamo vivendo. Il romanzo racconta storie
personali e di povertà che risalgono fino agli inizi del Novecento,
accompagnato da una riflessione su quello che eravamo e poi non siamo
più riusciti a essere.»
Mauro Covacich, Di chi è questo cuore, La nave di Teseo – proposto da Loredana Lipperini;
«Di chi è questo cuore forza e supera i confini di quella che
oggi chiamiamo autofiction iscrivendosi in un progetto artistico che
Covacich persegue da anni, e si pone anzi come culmine della sua intera
opera. La scoperta da parte dell’io narrante di una lieve anomalia
cardiaca è il punto di partenza per un’esplorazione lucida e inquieta,
che può soffermarsi a scrutare il mondo degli affetti e sollevarsi a
guardare lontano, verso le piccole e grandi indifferenze del nostro
presente. È uno sguardo che si rivolge ai molti ultimi delle città (i
senzatetto e i lavavetri che abitano Roma, dove i condomini possono
decretare la mutilazione degli alberi per decoro, ma ignorano le vite
piccole che si muovono nelle strade e negli argini del fiume), e che
insieme guarda alla mutazione che il tempo impone ai corpi e allo stare
nel mondo. È uno sguardo che legge, nettamente e con passione,
soprattutto i cambiamenti dei corpi femminili, che si votano a un’ascesi
che li scolpisce e smaterializza o ritrovano entusiasmi di ragazza pur
nella vecchiaia (e le donne appaiono qui anche come flatus vocis, attraverso le parole di Anne Frank e di Etty Hillesum). Per linguaggio, stile, profondità e innovazione formale, Di chi è questo cuore si pone tra le prove più alte nel panorama letterario contemporaneo.»
Irene Di Caccamo, Dio nella macchina da scrivere, La nave di Teseo – proposto da Paolo Di Paolo;
«Una grande poetessa americana, Anne Sexton, la sua vita turbolenta,
«furiosa, erotica, caotica e libera», è raccontata nelle pagine di Dio nella macchina da scrivere
con l’azzardo della prima persona. Non è una biografia romanzata; è un
diario immaginato e costruito per “evocazione”: Irene Di Caccamo
reinventa la voce di Anne Sexton, nel senso proprio che la riporta in
luce, la rende ancora udibile. E proprio perché intemperante, indomita,
poeticissima questa voce rifiuta ogni cliché, non si lascia ingabbiare
dagli stereotipi. Si muove liberamente, vibra, si accende, asseconda i
balzi in alto e in basso dell’umore, traduce visioni, allucinazioni,
ricordi. Irene Di Caccamo, con questo romanzo, porta il lettore in quel
paesaggio psichico affascinante, misterioso – carico di sogni, di
incubi, di desideri – che sta dietro alla creazione artistica. È un
paesaggio che di solito ci è dato solo intuire, supporre, immaginare:
qui lo esploriamo. Ed è stupefacente. Anche doloroso, perché
insostenibile per chi lo abita ogni giorno. Le immagini ambigue, i
simboli sinistri, le ossessioni, i lampi ironici e spiazzanti della
poesia singolare e intensissima di Anne Sexton, morta suicida nel 1974,
sono come rivelati e tradotti in racconto da questo coraggioso romanzo
di voci.»
Francesca Diotallevi, Dai tuoi occhi solamente, Neri Pozza – proposto da Gianfranco De Bosio;
«Nel romanzo Dai tuoi occhi solamente l’autrice, prendendo spunto
da un personaggio realmente esistito, ne rielabora la vicenda; ne
riscrive la storia sia relativa al vissuto personale della protagonista,
sia al contesto della New York degli anni Cinquanta. Questo romanzo,
opera di finzione è dal punto di vista narrativo coinvolgente.»
Antonio Dikele Distefano, Non ho mai avuto la mia età, Mondadori – proposto da Simonetta Bitasi;
«Senza dubbio Antonio Dikele Distefano è uno scrittore, un talento naturale che in Non ho mai avuto la mia età
mostra grande maturità stilistica e la capacità di misurarsi con un
romanzo dalla struttura tradizionale. Grazie soprattutto a una scrittura
densa ed efficace che non rinnega la frammentarietà e le frasi ad
effetto delle opere precedenti, ma riesce a metterle al servizio di un
respiro narrativo coerente, evitando così di perdere l’intensità e la
forza poetica che caratterizzano l’autore. Non ho mai avuto la mia età
è un romanzo necessario perché è la voce di una generazione non solo
inascoltata ma del tutto incompresa, gravata di doveri ma privata dei
diritti, una generazione di italiani che amano il nostro paese ma dal
quale si sentono sempre respinti: «Avrei voluto andare via dall’Italia,
via fa questa strana casa dove sono nato e cresciuto e che mi ha sempre
chiesto dove vivessi e da dove fossi venuto». Antonio Dikele Distefano
li rappresenta con una voce intensa e potente, che non induce mai nel
pietismo ma fotografa con una veridicità spietata la loro e la nostra
realtà. Il talento di Antonio Dikele Distefano inoltre ci conforta sul
futuro della narrativa italiana e sulla sua capacità di saper raccontare
il nostro paese.»
Claudia Durastanti, La straniera, La nave di Teseo – proposto da Furio Colombo;
«Il romanzo merita attenzione per tre aspetti del tutto insoliti (oltre
all’insolito percorso biografico e di lavoro dell’autrice, che è e non è
una straniera). Il primo aspetto è certamente il linguaggio. Riflette
in modo curioso (sorprendente ) una vita, in modo più efficace di un
sequenza di notizie. È un linguaggio lontano-vicino, familiare ed
estraneo, molto bello e senza alcuna preziosità o deliberata ricerca di
stile. Una seconda ragione è la storia, che appartiene, allo stesso
tempo, al genere “familiare” ma anche a una sequenza di avventure con
scarti sorprendenti rispetto all’attesa abilmente creata. Ovvero si
carica e si libera della memoria personale e familiare, spingendo
continuamente il lettore a rifare la mappa del mondo e del tempo che sta
percorrendo. Infine merita attenzione il talento espressivo (che non è
il linguaggio, ma la costruzione del racconto) che rende La Straniera non una raccolta di memorie, ma il punto in cui nasce (anche, ma non solo da ciò che è accaduto) una storia nuova.»
Marinella Gargiulo, Il diario di Antossia, Guida editori – proposto da Marcello Rotili;
«Marinella Gargiulo, scrittrice con una solida formazione storica ed una
lunga esperienza nella didattica di genere, è l’autrice di un
avvincente romanzo su Antonia (Antossia) Kwiatkowski Bakunin, vedova,
dal giugno 1876, del celebre rivoluzionario russo, principe Mikhail
Bakunin, e dal febbraio 1879 moglie dell’avvocato napoletano Carlo
Gambuzzi, padre naturale dei suoi primi tre figli e padre legale
dell’ultima, nata dopo il matrimonio. Scritto nella forma di un diario
che copre il periodo dall’estate del 1865 all’aprile 1887, l’ultima
stagione della vita di Antossia che scomparve il successivo 2 giugno,
l’avvincente racconto muove dall’incontro in Siberia, ove viveva la sua
famiglia (il padre era un nobile polacco della Russia Bianca, esule),
con il grande rivoluzionario quarantatreenne, deportato a vita in quella
sperduta regione dell’impero zarista dopo lunghi e tormentati periodi
di carcerazione. Dal momento in cui Bakunin incominciò a frequentare la
casa della sedicenne Antossia, l’Autrice tesse la trama
dell’innamoramento e del matrimonio, celebrato nel 1858 nella
Chiesa della Resurrezione di Tomsk in Siberia, e attraverso alcuni
densi capitoli iniziali che inquadrano la biografia familiare del
rivoluzionario-marito, i primi felici anni di matrimonio in Siberia, la
fuga di Mikhail a Londra, il ricongiungimento con la moglie a Stoccolma e
infine l’arrivo in Italia, risale dall’estate del 1865 al 1887,
seguendo le tappe fondamentali di una vicenda umana e politica sofferta,
che si svolge fra l’Italia e la Svizzera e per Antossia e i suoi figli
anche in Siberia per un paio d’anni. Non furono solo le difficoltà
economiche e le privazioni a condizionare la vita della famiglia, ma
anche e soprattutto l’isolamento morale di Antossia rispetto all’area di
riferimento sociale e intellettuale del marito. Del resto se le
biografie di Bakunin rimproverano ad Antossia la sua relazione con il
coetaneo Carlo Gambuzzi, tacendo sull’impotenza sessuale del marito,
dagli archivi sono emersi documenti chiarificatori, come la lettera del
16 dicembre 1869 di Bakunin a Ogareff: un racconto-confessione di un
mariage blanc e della sua accettazione della famiglia allargata, testimonianza
inequivocabile della consapevolezza e della complicità da parte del
rivoluzionario, dettata peraltro non solo dalla necessità ma soprattutto
dall’affetto per la moglie e i figli nati da Gambuzzi e dal suo grande
bisogno del calore e della
serenità che solo la famiglia poteva dargli. Nel racconto che l’Autrice
abilmente intreccia con la storia sociale e ideologica di un trentennio,
dal 1857 al 1887, segnato dalle passioni e dalle sconfitte
rivoluzionarie in Europa e in Russia, dai moti risorgimentali e dalla
nascita dello stato unitario nella Penisola, dalle devastanti epidemie
di colera a Napoli nel 1865 e nell’84, la scrittura e la voce della
protagonista Antossia sono in realtà quelle di Marinella Gargiulo: in un
credibile e ben costruito gioco letterario di rimandi, la Gargiulo
esprime un sentire femminile contro i pregiudizi di genere comune ad
Antossia, a lei stessa e a tutte le donne desiderose di riscatto che
possono, per tanti versi, identificarsi nella sofferta
e umanissima vicenda della moglie di Bakunin. Nel fare ciò la Gargiulo
sembra sostanzialmente dissentire dal comportamento della peraltro
coraggiosa Marussia Bakunin, la seconda figlia di Antossia che fu
prestigiosa cattedratica nell’Università di Napoli e che rivendicò
sempre la discendenza dal grande rivoluzionario. Pur non essendo neanche
una protagonista secondaria del racconto, Marussia Bakunin che
l’Autrice ha conosciuto nella sua adolescenza attraverso le informazioni
attinte dai suoi più stretti familiari, è sostanzialmente la
controparte conformista, anche se giustificata da esigenze sociali, di
Antossia e della stessa Marinella Gargiulo che al comportamento di
quest’ultima rende giustizia postuma. Il suggestivo racconto-diario
merita, a mio modo di vedere, la massima considerazione per
l’originalità, l’efficacia narrativa e “il sentire di genere” che lo
distinguono. »
Marco Giannini, Mario e il suo doppio, Biblioteca dei Leoni – proposto da Maurizio Cucchi;
«Marco Giannini ha costruito un romanzo aperto e felicemente originale nella struttura. Mario e il suo doppio
è la storia di un architetto che registra in un diario gli eventi della
sua realtà, ampliandola però con la creazione di racconti spesso
fantasiosi. Il diario diviene un suo compagno segreto e i racconti
spaziano libere nelle situazioni più varie, un po’ (ma con toni
diversissimi) come nel De Amicis di Cuore. L’estro e la viva fantasia dell’autore si realizzano nell’equilibrio di una scrittura molto precisa ed elegante.»
Pier Paolo Giannubilo, Il risolutore, Rizzoli – proposto da Ferruccio Parazzoli;
«Per la perturbante libertà di quanto è narrato e per la forza del
racconto, il libro di Pier Paolo Giannubilo si presenta come una
sorprendente novità. L’autore chiede di seguirlo attraverso i percorsi
del protagonista dall’inaspettato cognome: Gian Ruggero Manzoni è,
infatti, il pronipote di Alessandro. Una curiosa parentela che desta
viva dissonanza con gli accadimenti che ripercorrono gli anni, appena
trascorsi, d’intensi e destabilizzanti scuotimenti. L’autore convince il
suo avventuroso personaggio a riversare il fiume delle proprie
esperienze, la sua vita di individualista che ama egualmente il rischio e
l’amore, la scena internazionale e quella di famiglia. Storie
contrastanti: i moti politici e studenteschi del ’77, gli incontri con
personaggi simbolo di quegli anni, Tondelli, Pazienza, le simpatie per
il sinistrismo di azione, i terrori della prigionia, l’entusiasmo, più
che la costrizione, a divenire risolutore di estreme situazioni, quale
informatore sotto copertura, in Libano,
e nei Balcani. Difficile trovare oggi nella narrativa italiana chi
abbia, come Pier Paolo Giannubilo, un vivificante senso anarchico della
letteratura, la libertà di trasformare la realtà in finzione e la
finzione in realtà.»
Davide Grittani, La rampicante, LiberAria Edizioni – proposto da Giulia Ciarapica;
«La rampicante di Davide Grittani non è soltanto un romanzo ma
un’autentica presa di coscienza, poiché attraversa la realtà della vita –
dura, a tratti spietata – affrontando temi di grande interesse
collettivo. Uno su tutti, il trapianto degli organi: inteso e vissuto
non come fatto scientifico, ma come trasferimento di un insieme di
sentimenti, e relative conseguenze, da una persona ad un’altra (è tra i
pochissimi libri ad essersi occupati di questo, dal dopoguerra ad oggi).
Nel trattare un argomento così scomodo e così delicato, Grittani prende
posizione ma, al contempo e con coraggio, lascia agli interpreti de La rampicante ogni possibile riflessione sulla convivenza tra etica e necessità, tra destino e fede. La rampicante
è ispirato a una storia vera e, probabilmente anche per questo, in
tutto il romanzo si avverte in modo netto una continua ricerca di verità
e fors’anche di giustizia. C’è poi un’altra questione di fondamentale
importanza all’interno del romanzo, che ruota attorno al concetto di
genitorialità. Cos’è una famiglia? Che luogo è, o diventa, se viene
vista attraverso gli occhi di un bambino adottato? Il territorio minato
dell’infanzia e del rapporto padri-madri-figli, ieri come oggi, viene
discusso da Davide Grittani con grande empatia ma soprattutto con
estrema lucidità.»
Sandro Gros-Pietro, Fratello cattivo, Neos Edizioni – proposto da Corrado Calabrò;
«In tempi in cui il fanatismo religioso giustifica nella coscienza degli autori i più efferati delitti col miraggio dell’al di là, rischiamo di dimenticarci di un altro dio immanente alla nostra società: il dio denaro. E’ lui, il dio Mammona, il vero dio cui obbediscono i comportamenti della maggior parte degli uomini e soprattutto degli uomini di successo. Absconditus deus,
ma non per questo meno assoluto, costantemente presente nelle
intenzioni e negli atti dei suoi ministri, che professano devotamente,
ancorché non dichiaratamente, la loro totale dedizione a quell’unico
dio; il resto è solo mascheramento della loro devozione. Il protagonista
del romanzo di Sandro Gros Pietro, Fratello cattivo, butta via
la maschera. Sostituisce risolutamente i Dieci Comandamenti con i Dieci
Fondamenti della Ricchezza, divinità della quale si autoconsacra
sacerdote e che gli fornisce un alibi per ogni misfatto, avendo come
obiettivo l’al di qua.Il protagonista di questo romanzo, la sua
storia, la sua dissimulata autoreferenzialità sono narrati da Sandro
Gros-Pietro in un modo incalzante e coinvolgente, sull’orlo della
nevrosi.»
Chiara Ingrao, Migrante per sempre, Baldini + Castoldi – proposto da Luciana Castellina;
«Negli ultimi tempi, nei più importanti festival cinematografici, si moltiplicano i film che i francesi definiscono Cinéma du réel.
Altrettanto sta accadendo anche in letteratura, dove si diffonde un
genere nuovo di narrativa, che non è puramente finzione, ma neppure
semplice cronaca. Se il libro è bello, al piacere dell’intreccio
romanzesco si aggiunge il gusto di scoprire che è una storia vera. Nei
premi letterari degli ultimi anni, è proprio questa la novità. Questa
premessa per spiegare che cos’è Migrante per sempre di Chiara
Ingrao, che si apre con i passi nella notte di un clandestino mentre
varca la frontiera di Ventimiglia: è il padre della protagonista, Lina,
di cui l’autrice ha raccolto la storia. Lina è una bambina che nasce
nella Sicilia contadina dei poverissimi anni ’50, il tempo
dell’emigrazione massiccia verso l’Europa del Nord, dove anche lei sarà
obbligata ad approdare ancora adolescente, strappata al suo paese, alla
nonna, alla scuola e a un possibile, più felice avvenire. Nella Germania
gelida e ostile si riacutizza il conflitto con una madre amata e
odiata, che prima l’ha abbandonata per emigrare e ora le impone la
durezza del lavoro in fabbrica, che spezza i sogni e rende difficile
ridare senso e speranza alla propria esistenza. Ostinata e ribelle, Lina
conquista poco per volta, attraverso incontri umani diversi e
un’esperienza associativa, una nuova sicurezza, anche nel rapporto con
gli uomini, che le fa vivere una stravagante ma durevole storia d’amore.
È già madre e moglie quando torna in Italia. Ma proprio a questo punto
scopre che ci si può sentire stranieri anche nel proprio paese, e che la
determinazione a trovare la propria strada è un percorso lungo e
impervio, nel lavoro, nella famiglia e nel rapporto con se stessa.
Chiara Ingrao ci racconta la Sicilia, la Germania e Roma, mescolando i
linguaggi e i tempi della vita, che ritrova una compiutezza nella sua
linea spezzata: perché Lina resta siciliana, ma continua a portare
dentro di sé l’eco di altre voci e altri mondi. Come le dice l’amica
peruviana Rosario: «Non sono gli altri a trattarmi da straniera: sono io
che ho attraversato troppi luoghi e troppe tribù, per poter scegliere
di appartenere a una sola».
Fabrizia Lanza, Tenerumi, Manni Editori – proposto da Cesare Milanese;
«Con Tenerumi di Fabrizia Lanza, il genere letterario
dell’autobiografia ha un suon testo esemplare: come narrazione di sé e
delle cose, come riflessione ragionata su di esse e come documento della
realtà effettiva. È un libro, questo, tutto da materia da saga: quella
personale dell’autrice, dovuta allo status della sua famiglia nella
storia profonda della Sicilia (in realtà più famiglie: Lanza, Mazzarino,
Tasca, Lampedusa – sì proprio quella dell’autore del Gattopardo…);
e la saga del continente Sicilia nel suo insieme senza distinzione di
classe o di censo intorno alla più primordiale delle simbiosi, quella
della condivisione della cultura del cibo come alimento d’identità di
tale insieme, sedimentata nel corso della storia. Limpido nella
scrittura, semplice nella composizione, lineare nella trattazione,
questo Tenerumi ha in sé tre cose che lo qualificano: il bello
della scrittura, l’autentico della realtà, il buono del cibo; con tre
fini conseguenti: il piacere del cibo, il piacere del vivere e il
piacere del testo. L’autrice stessa qualifica tutto ciò come dimensione
dell’eros. Non ci sono ricette di cucina in questo libro, ma solo
descrizione dei cibi per i loro sapori, per i loro aspetti e per i loro
effetti, esteriori ed interiori: godurie del corpo e beatitudini dello
spirito. Va precisato che l’effetto di potenza, da espressione
letteraria, è ottenuto soprattutto dalla pura e semplice elencazione dei
nomi dei piatti, delle vivande e delle portate, che irradiano una
suggestione immediata da trascinamento nella meraviglia e nello stato da
stupore, che sa più di magia che di gastronomia. Difatti, Jung alla
mano, è evidente che il lavorio di cucina equivale a un cerimoniale
alchemico da processo d’individuazione del sé, dove la pentola funziona
da atanòr. Certo, non manca anche il versante freudiano, in quel
rapporto da intrico problematico e affettivo da romanzo di formazione e
di trasmissione di una Kultur e di un ethos, il culto-cultura
della cucina di tradizione, che l’autrice, storica dell’arte, pittrice,
dall’imprinting cosmopolitico, apprende dalla madre Anna e costei a sua
volta da sua madre e da tutto il genus delle famiglie unite dalla
stesso ceppo: problematica da manuale psicoanalitico, che costituisce
l’aspetto della saga di famiglia. Aspetto che l’autrice gestisce
alternando il mestolo con la penna, strumenti che esperienzialmente,
oltre che culturalmente si equivalgono: tanto da auto-convincere se
stessa a farsi “maestra di pensiero” come imprenditrice di una Scuola di
cucina, dedicata alla cucina di tradizione antica, però con l’intento,
da portata epica, si può dire, di preservarla anche in futuro
suggerendola e perciò inserendola nelle “ingredienze” della futuribile e
superscientifica cucina molecolare. Il futuro potrà avere così un
“sapore” antico?»
Oreste Lo Pomo, Malanni di stagione, Cairo Editore – proposto da Maria Cristina Donnarumma;
«Oreste Lo Pomo nel suo romanzo Malanni di stagione con ironia e
amarezza tratta il tema della malagiustizia attraverso una storia di
ordinaria ingiustizia che vuole dare voce ai tanti uomini comuni
dimenticati negli archivi dei tribunali. Il protagonista, Davide,
giornalista di cronaca giudiziaria, entusiasta del suo lavoro, viene
sconvolto nella sua piatta quotidianità, fatta di lavoro e famiglia, da
una notizia che lo coinvolge molto da vicino, infatti ii suo amico
Marco, giovane funzionario comunale, un uomo come tanti, si sarebbe
lasciato corrompere da un imprenditore per cui è finito
inconsapevolmente nelle spire della giustizia e della burocrazia. Davide
e Marco sono amici dalle elementari, le loro mogli sono diventate molto
amiche e le loro bambine, coetanee, frequentano lo stesso asilo. Marco è
un’esca nelle mani dei PM che puntano a bersagli molto più grossi e per
raggiungerli rigirano tra le mani l’ esistenza altrui. La vicenda si
svolge in una città di provincia, una come tante, con i suoi pregi e i
suoi difetti, i suoi riti, le sue consuetudini ed anche i suoi
pregiudizi, in cui le notizie rimbalzano dal bar al giornale locale, la
gente mormora, le voci corrono e ognuno si sente in diritto di
pronunciare la propria sentenza. Per Davide non è facile gestire la
situazione e non sa come aiutare il suo amico, da cronista giudiziario
di casi re ha visti tanti ma sempre con un certo distacco, ora per la
prima volta vede tutto con occhi nuovi, anche perché il Direttore del
giornale, pusillanime e servo del potere, tiene lontano Davide dalla
vicenda sapendolo troppo coinvolto e immaginando che cercherà la verità
ad ogni costo, andando anche contro la Magistratura e i poteri forti. Un
romanzo spietato nel rievocare il dramma delle manette, usate con
troppa disinvoltura e spietato anche nel sottovalutare il dolore
inespresso di Davide. È insomma un romanzo amaro, soprattutto nella
considerazione che la vicenda è tanto ordinaria quanto quotidiana,
infatti potrebbe riguardare chiunque.»
Gordiano Lupi e Cristina De Vita, Sogni e altiforni. Piombino-Trani senza ritorno, Acar Edizioni – proposto da Paolo Ruffilli;

«Un’epoca industriale tramontata fa da sfondo alle storie parallele del
romanzo che Gordiano Lupi ha scritto a quattro mani con Cristina de
Vita, Sogni e Altiforni, e che porta un sottotitolo significativo: Piombino-Trani senza ritorno.
Il romanzo in realtà si può considerare una storia unica che ha due
punti di vista, per molti aspetti tali da combaciare. Il doppio
racconto, intenso e coinvolgente nella sua dimensione elegiaca, è un
recupero del tempo passato con i suoi ricordi, con le sue promesse e con
i suoi sogni, con le sue attese e illusioni poi andate perdute ma con
una carica che, nonostante il bilancio negativo del presente, continua
ad alimentare le ragioni della vita. Nella consapevolezza che il passato
siamo noi e che è per noi vitale il vivere con i ricordi, non di
ricordi.»
Leonardo Malaguti, Dopo il diluvio, Exòrma Edizioni – proposto da Letizia Tortello;
«La strada, d’altro canto, era ben più ostile del bosco». E come non
pensarci: chi è davvero la selva oscura e misteriosa, se non noi? Le
insidie feroci si annidano lì, nello spazio abitato costruito dall’uomo,
nella più piccola polis che ha il nemico alle spalle, ma anziché
combatterlo compatta, si perde nelle miserie di una convivenza civile
deteriorata. «Ben venga il caos, poiché l’ordine non ha funzionato»,
diceva Karl Krauss. E allora eccoci, tutti spettatori della vita di un
paese incastrato in una conca sommersa dall’acqua, reduce da un
insolito, buffo diluvio. Dove i protagonisti sono fatti di un’umanità
esasperata, e tirano avanti impermeabili alle calamità, alla carestia,
all’isolamento, come marionette in un carillon. Siamo in una modernità
senza tempo, da qualche parte nella Mitteleuropa di inizio ‘900, con le
armi da fuoco, le sigarette, il furgoncino del latte, il sindaco, gli
assessori e il consiglio comunale. Ci sono il pastore, il rabbino, il
soldato, ci sono le donne forti come Lisetska o la giovane Nana, e un
omicidio. Il villaggio sperduto è una pozza melmosa: c’è qualcosa che
ottura la valvola del canale di scolo. Siamo al tempo stesso in un
oscuro Medioevo, in cui la cattiveria e i vizi hanno le pallottole
spuntate e sono diventate abitudine. I cuori sono rattrappiti dal freddo
e dalle scomodità. Dopo il diluvio di Leonardo Malaguti è un
quadro di Bosch in cui Orson Welles ha dato vita ai protagonisti. Con
una scrittura incredibilmente matura, questo autore 26enne, che ha
composto su carta le prime scene della sua opera d’esordio, porta il
lettore in uno spassoso mondo lontano, ma neanche troppo. I personaggi
grotteschi tengono compagnia ad ogni pagina, chiusi nelle loro sciagure,
e meritano invero uno sguardo più profondo, che ha i tratti accennati
di una fulminante critica al nostro tempo. Come in un gioco con i
mattoncini Lego, l’autore fa travalicare i registri, in una continua
sorpresa: la comicità antica e il giallo, il romanzo apocalittico, la
tragedia che diventa farsa. Tutto si tiene, ma bando ai moralismi.
Malaguti di mestiere fa anche il regista, di teatro e cortometraggi. In Dopo il diluvio
sono evidenti il ritmo e la potenza espressiva del cinema. Un vero
spasso da cronache dalla fine del mondo, o per nostra fortuna poco
prima.»
Marina Mander, L’età straniera, Marsilio – proposto da Benedetta Tobagi;
«Perché leggiamo romanzi? Come antidoto alla solitudine esistenziale,
per trovare, nelle pagine, noi stessi; per poterci riconoscere, trovare
parole per la nostra ombra, per sentimenti così sottili da non avere
nome, o una ferita segreta, diranno alcuni. Per vivere «vite che non
sono la mia», incontrare l’alterità totale, estendere l’empatia oltre i
confini dei territori a noi familiari, diranno altri. Più spesso, tutt’e
due le cose. Il primo elemento di grande fascino de L’età straniera
di Marina Mander sta nel fatto di consentirci entrambe le esperienze,
trascinandoci – sospesi, incerti – nella penombra di uno spazio
liminale, nella schiuma tra terraferma e mare, come nell’immagine di
copertina. Perché il protagonista, Leo, è un adolescente: età di
metamorfosi e di estremi, in cui ciascuno è straniero a se stesso come
mai, prima e dopo, nella vita. Marina Mander ci mostra il mondo
attraverso il suo sguardo, che penetra la realtà come un coltello e ha
la cruda verità del sole meridiano, o delle luci al neon (che lui odia,
per le tragedie di cui sono state mute testimoni), uno sguardo
invecchiato dal precoce disincanto – ma senz’ombra di cinismo – e
insieme fresco, persino ingenuo, nei mille dubbi di chi si affaccia alla
vita. Uno sguardo che prende vita, sulla pagina, in una voce
sorprendente, caleidoscopica, sempre ironica e dissacrante. La
quotidianità di Leo per certi versi è molto normale (per quanto si possa
parlare di “normalità”, tra le mille contraddizioni del presente): vive
con la madre e il compagno di lei – tassista e tanguero – nella Milano
dei primi anni Duemila, in un quartiere medio, fa il liceo classico
(dove brilla, anche se studia poco), si fa qualche canna (e racimola
qualche soldo vendendo l’erba agli amici), ha una passione per Kurt
Cobain ed è ossessionato dal pensiero di non aver ancora mai fatto
sesso. Ma questa patina sottile si lacera a ogni piè sospinto
nell’attrito con la verità abnorme, incommensurabile che giace sotto la
superficie: il padre, molto amato, di Leo, un matematico geniale che
era, semplicemente, troppo per la vita, si è suicidato
affogandosi in mare. Ed ecco che, come il velo della realtà, la
tessitura pulsante del racconto, tra sequenze lente e busche ellissi in
accelerazione, si spezza, interrotta – invasa – dal teatro interiore dei
suoi incubi in cui si celebra un assurdo processo permanente (un po’
Kafka, un po’ Lewis Carrol, per l’umorismo surreale), e Mander mostra
grande acume psicologico e delicatezza nel trovare parole per il mondo
interiore del trauma, per ciò che accade nelle anime travolte troppo
presto dall’incommensurabile, divorate da un senso di colpa senza fondo –
perché non ha fondamento. Per colmare il vuoto in ogni senso possibile,
nel moto perpetuo di un iperattivismo pieno di buone intenzioni con cui
sembra costantemente impegnata ad allontanare il dolore, la madre di
Leo, dopo un periodo di volontariato con i prostituti minorenni che si
vendono al Mercato ortofrutticolo e nella “fossa” vicino al parco
Sempione, decide di prendere in casa uno di loro, Florin, un ragazzo
rumeno della stessa età di Leo. Florin è brutto, magrissimo, non parla
italiano, non si capisce mai cosa pensi (per questo Leo lo ribattezza
Iwazuru, la terza delle tre scimmiette dell’antico adagio «Non vedere il
male, non sentirlo, non parlarne»), pur avendo una sua speciale
delicatezza: è l’alterità assoluta che irrompe, imprevista, nella
quotidianità di Leo e, attraverso lui, nella nostra. Non c’è nulla di
scontato nel modo in cui il giovane io narrante scruta il nuovo
arrivato, lo detesta, talvolta imprevedibilmente lo invidia (il che, con
semplicità disarmante, fa ricordare quanto l’ostilità verso il diverso
sia spesso la schiuma sporca che monta sopra fragilità e frustrazioni),
si fa intenerire e ne resta continuamente sorpreso, durante i loro
vagabondaggi a casaccio nei luoghi marginali della città. Florin diventa
sempre più la cartina di tornasole che mette a nudo le ipocrisie del
mondo adulto, mentre, per gradi, qualcosa in Leo cambia. Si sblocca. Con
umorismo, scansando i luoghi comuni con la grazia (apparentemente)
casuale di un gatto, l’Età straniera regala uno sguardo diverso
su come sia possibile incontrarsi con ogni tipo di “straniero”, forse
soprattutto con quello (il più spaventoso, repellente, inquietante di
tutti) nascosto dentro di noi.»
Nicola Manuppelli, Roma, Miraggi Edizioni – proposto da Filippo La Porta;
«Roma di Nicola Manuppelli è un romanzo che sta a Roma come la
perla incollata all’ostrica. Riunisce Verdone (che l’ha molto amato) e
Sorrentino, Fellini, Scola e Flaiano. Nel 1970 l’apprendista giornalista
Tommaso, dopo la bomba di Piazza Fontana, sceglie di trasferirsi a Roma
per ricominciare daccapo. Roma si distende davanti a lui: vitalista e
funerea, sguaiata e tollerante, cialtrona e monumentale. E c’è la
stregante saggezza di una città-palude, dove si sa che tutti, ma proprio
tutti “so’ stati morti prima d’esse vivi” (Belli, ragionando sul fatto
che la nostra testa contiene un teschio). Una topografia minuziosa e
affettiva: luoghi, ruderi, cinema d’antan, trattorie, palazzi, locali
jazz… E poi una galleria brulicante di personaggi che entrano ed escono
dalla mitologia urbana. Proprio nel mondo un po’ reale e un po’ onirico
di Cinecittà Tommaso inizia ad occuparsi di gossip in compagnia delle
ombre di personaggi leggendari un po’ straniati (Burt Lancaster, Gregory
Peck…), nel fascino dei set cinematografici, attraverso le conoscenze
artistiche e personali che lo segneranno a vita. Manuppelli ha voluto
usare fin dall’inizio una bugia, una falsa citazione, per raccontare in
modo veridico la città bugiarda. Il suo naturalismo visionario è forse
l’unica lingua per raccontare una Roma eternamente franante.»
Eleonora Marangoni, Lux, Neri Pozza – proposto da Sandra Petrignani;
«Questo romanzo di Eleonora Marangoni è pieno di cose inaspettate. Tu ti
dici: ah, ecco, l’autrice ricorre al tema classico dell’isola lontana
dove si ritrova un gruppo mal assortito di persone e pensi che
succederanno fatti prevedibili. Invece no. Il topos è evocato da lei
giusto per posizionarsi nella grande corrente della letteratura (e ne
senti spesso le antiche risonanze), ma poi ti spinge verso un viaggio
inatteso, dove si assiste soprattutto al gioco altalenante delle
relazioni, si simpatizza con questo o quel personaggio, e si finisce con
l’abbeverarsi a una fonte di acqua minerale – centrale nella storia –
soltanto perché affascinati dall’etichetta sulle bottiglie che la
narratrice ci descrive. Marangoni conosce l’arte finissima di rendere
reale l’immaginario, riesce a farti credere nella presenza di una nuvola
in salotto più che nella forza dei sentimenti che legano un certo uomo a
una certa donna. Insomma come di ogni libro complesso, non è facile
parlare di Lux: è stravagante, allegro e malinconico, sapiente e
leggero. C’è dentro una voce sferzante, ironica, saggia, che si muove
sul solido terreno di radici letterarie comuni per proiettarsi in un
oltre giovanissimo e carico di futuro.»
Cristina Marconi, Città irreale, Ponte alle Grazie – proposto da Masolino d’Amico;
«È il debutto nella narrativa di una giovane che si è già mesa in luce
come giornalista, soprattutto con le sue corrispondenze da Londra, e
questo libro è particolarmente interessante proprio per la sua
ambientazione nella città-mito delle aspirazioni di tanti Rastignac dei
nostri giorni alla ricerca dell’Eldorado. Dopo essere stata swinging
negli anni sessanta, con i Beatles e Carnaby Street, Londra tornò ad
essere un polo di attrazione negli anni novanta e duemila, quando
nell’epoca post-Thatcher diventò una delle capitali della finanza
mondiale. Da allora questo luogo dalle mille opportunità attira da tutto
il mondo emigranti di ogni tipo, e la narrativa si è spesso occupata
delle loro vicissitudini, in particolare puntando su quelli provenienti
dal cosiddetto terzo mondo. Meno frequente il trattamento di un caso
come quello della protagonista di Città irreale, che proviene da
una fascia socialmente più elevata, quella (non meno numerosa) dei
professionisti qualificati che semplicemente non trovano in patria
occasioni di lavoro all’altezza della loro preparazione. La Alina di
Cristina Marconi si vede quasi costretta a lasciare la sua Roma, nella
quale peraltro si trova benissimo (ma dove suo fratello sta per perdere
il suo impiego) per misurarsi in un contesto del tutto nuovo, che
affronta con coraggio e con curiosità. La sua storia è quella di una
formazione anche sentimentale, che dura alcuni anni e che viene
raccontata a capitoli alterni, dalla voce della stessa Alina e da quella
di un altro narrante che in terza persona ripercorre le vicende
precedenti di altri personaggi il cui destino si mescolerà al suo.
Mantengono vivo l’interesse nelle tappe di questa formazione gli
incontri con esponenti della fauna internazionale che agisce nella città
non poi tanto irreale del titolo, sempre descritti con un occhio
attento a molti particolari rivelatori e con una prosa autorevole, da
scrittore in pieno controllo del suo strumento espressivo.»
Titti Marrone, La donna capovolta, Iacobellieditore – proposto da Marina Zancan;
«Eleonora, cinquantotto anni, donna emancipata e colta – insegna
filosofia all’università, attenta alle prospettive degli studi di genere
– ha una figlia, Laura, che studia all’estero, e un marito, Paolo,
sullo sfondo della sua vita quotidiana. Alina, moldava (ma da dieci anni
in Italia come badante), a sua volta emancipata e colta – laureata in
ingegneria elettronica e appassionata di letteratura (Dante in
particolare, suo maestro per l’apprendimento della lingua italiana) – ha
anch’essa un figlio Misha che studia a Barcellona e un marito sullo
sfondo della sua terra d’origine. Tra Eleonora ed Alina – che nel
romanzo di Titti Marrone raccontano in prima persona i riflessi
interiori delle proprie esperienze quotidiane – si dispone la figura di
Erminia, donna anziana affetta da una malattia degenerativa, madre di
Eleonora, affidata alle cure di Alina, la badante. La sua vicenda –
narrata in terza persona in brevi capitoli intitolati Loro – si dispone
dunque all’interno del rapporto complesso e sempre più conflittuale tra
Eleonora ed Alina, ognuna proiettata nel proprio ruolo, la padrona e la
badante, una diversità che a tratti sembra tutelarle dalla conoscenza
profonda di sé. Nell’intreccio delle voci e dei punti di vista emerge un
racconto lieve e insieme profondo, ironico e a tratti tragico che
racconta, oltre ai temi della vecchiaia, le difficoltà che emergono in
ogni processo di integrazione sociale. »
Marco Missiroli, Fedeltà, Einaudi – proposto da Sandro Veronesi;
«Ci sono romanzi che sembrano provenire dal futuro. Romanzi che sembrano
ritornare a noi, qui e oggi, da un tempo nel quale finalmente molti
problemi sono stati risolti, cioè ricondotti alla propria perduta,
primordiale naturalezza. Di questi romanzi si usa dire che “fanno
epoca”. Fedeltà di Marco Missiroli è uno di essi, e il nodo che
vi viene sciolto, nella scrittura soda e però anche fluida e lucente,
nei personaggi perfettamente definiti e però anche nella formidabile
trazione generata dalla loro dissolvenza l’uno nell’altro, è quello del
dolore: è energia vitale, il dolore, null’altro che energia vitale, e la
specie umana è concepita per trasmetterselo. Nelle sue pagine risieda
la risposta che solo la letteratura poteva dare allo stupore espresso da
Freud dinanzi all’incapacità della libido di separarsi dai suoi
oggetti, «uno di quei fenomeni che non si possono spiegare ma ai quali
si riconducono altre cose oscure». Il guaio non è soffrire, il guaio è
farlo nel modo sbagliato. La sofferenza in questo romanzo è come la
miseria in Céline: è liberatoria, viene voglia di viverla.»
Delia Morea, Romanzo in bianco e nero, Avagliano Editore – proposto da Diego Guida;
«Una scrittura fluida, a tratti cronachistica, dai contenuti profondi,
ricordando le sceneggiature di una grande stagione del cinema italiano,
Delia Morea racconta una storia di amore e amicizia, vita e morte,
all’ombra della grande Storia d’Italia. La vicenda si svolge a Roma nel
ventennio fascista scandito dalle leggi razziali e negli anni ‘70 del
Novecento: delusioni, dolorose separazioni, assenze, scomparse. Il libro
è anche un sentito omaggio al cinema italiano, ad alcuni dei suoi
maestri.»
Pasquale Panella, Naso, Fefè Editore – proposto da Giuseppe Antonelli;
«C’era una volta, e un po’ per tutti, la possibilità di essere assenti».
Il naso da Gogol agli arzigogoli di una lingua che si annulla in una
favolosa affabulazione: parole meravigliose, senza capo né coda: solo
naso. Perché in questo teatro dei sensi il senso non ha più significato.
È la lingua – il significante – a dominare l’ostentata assenza delle
cose, che hanno di noi di sentimento. Il teatro è olfatto di parole e di
tempo, perduto e perdurante. E alle parole dice: «non entrate in
tentazione di significare», abbiate il coraggio di riempire d’illusioni
pagine degne d’un illusionista. Solo così si arriverà dritti al cuore.
«Dire le cose fa più paura delle cose stesse.»
Laura Pariani, Il gioco di Santa Oca, La nave di Teseo – proposto da Luca Doninelli;
«Le ragioni per cui mi sono deciso a questo passo, per me non abituale, sono sostanzialmente due.
La prima è che Il gioco di Santa Oca è un libro molto bello e singolare, capace di offrire al lettore sia una storia esemplare, che celebra (come sempre fa, sopra o sottotraccia, la grande narrativa) la forza e la bellezza delle nostre esistenze individuali, l’inarrestabile energia che nasce dal nostro bisogno – spesso soffocato da mille Persuasori più o meno occulti – di essere i protagonisti della nostra vita, di non delegare a nessuno il nostro pensiero e la nostra presenza su questa terra; e insieme celebra la Memoria come grande alleata di questa necessità elementare. «Tutto cospira a tacere di noi» diceva Rilke nelle Elegie duinesi, ed è proprio così: si chiami clero, si chiamino social media, si chiami pensiero unico, si chiami identitarismo, c’è sempre qualcosa o qualcuno che vuole pensare al nostro posto. Il gioco di Santa Oca è un inno alla libertà di tutti colori che Vaclav Havel chiamava «i senza potere». La seconda ragione sta nella lingua con la quale Pariani «mima» il mondo (siamo nel Seicento lombardo) che ci racconta: una lingua folle e visionaria, spesso esilarante, che coraggiosamente mescola codici diversi, una lingua dell’ignoranza incapace di nascondere le proprie perfidie e porta alla luce dialetto, ecclesiale, lingua giuridica, germanismi, ispanismi, francesismi con buffi ammiccamenti ad espressioni che sono, viceversa, del nostro tempo. Che è, poi, l’essenza – affermata fin dal tempo del Porta e poi giù, con Gadda, Testori, il Fo di Mistero buffo, Pagliarani e non cancellata ma solo nascosta in filigrana perfino dal Manzoni – della lingua lombarda, che tutto è tranne che gelosamente identitaria. Il nostro splendido nord è tale perché da sempre spalancato a ogni vento, grazie alle «mal vietate Alpi», e non ha mai sopportato di autodefinirsi in confini culturali ristretti. Siamo insieme romani, cristiani, barbari e illuministi, fedeli perché eretici, eretici perché fedeli. Laura Pariani entra in questa scia con la brillantezza di cui solo chi è straniero al mondo è capace. E tale è Laura Pariani, per la quale mi permetto aggiungere una terza, personalissima motivazione. Questa eccellente scrittrice non ha ricevuto dalla cultura italiana nella misura in cui ha dato, sempre con generosità e senza fare calcoli (vizio che viceversa opprime molte menti brillanti del nostro Paese). Sarebbe giusto, a mio parere, restituirle qualcosa nella forma di un riconoscimento che merita abbondantemente.»
La prima è che Il gioco di Santa Oca è un libro molto bello e singolare, capace di offrire al lettore sia una storia esemplare, che celebra (come sempre fa, sopra o sottotraccia, la grande narrativa) la forza e la bellezza delle nostre esistenze individuali, l’inarrestabile energia che nasce dal nostro bisogno – spesso soffocato da mille Persuasori più o meno occulti – di essere i protagonisti della nostra vita, di non delegare a nessuno il nostro pensiero e la nostra presenza su questa terra; e insieme celebra la Memoria come grande alleata di questa necessità elementare. «Tutto cospira a tacere di noi» diceva Rilke nelle Elegie duinesi, ed è proprio così: si chiami clero, si chiamino social media, si chiami pensiero unico, si chiami identitarismo, c’è sempre qualcosa o qualcuno che vuole pensare al nostro posto. Il gioco di Santa Oca è un inno alla libertà di tutti colori che Vaclav Havel chiamava «i senza potere». La seconda ragione sta nella lingua con la quale Pariani «mima» il mondo (siamo nel Seicento lombardo) che ci racconta: una lingua folle e visionaria, spesso esilarante, che coraggiosamente mescola codici diversi, una lingua dell’ignoranza incapace di nascondere le proprie perfidie e porta alla luce dialetto, ecclesiale, lingua giuridica, germanismi, ispanismi, francesismi con buffi ammiccamenti ad espressioni che sono, viceversa, del nostro tempo. Che è, poi, l’essenza – affermata fin dal tempo del Porta e poi giù, con Gadda, Testori, il Fo di Mistero buffo, Pagliarani e non cancellata ma solo nascosta in filigrana perfino dal Manzoni – della lingua lombarda, che tutto è tranne che gelosamente identitaria. Il nostro splendido nord è tale perché da sempre spalancato a ogni vento, grazie alle «mal vietate Alpi», e non ha mai sopportato di autodefinirsi in confini culturali ristretti. Siamo insieme romani, cristiani, barbari e illuministi, fedeli perché eretici, eretici perché fedeli. Laura Pariani entra in questa scia con la brillantezza di cui solo chi è straniero al mondo è capace. E tale è Laura Pariani, per la quale mi permetto aggiungere una terza, personalissima motivazione. Questa eccellente scrittrice non ha ricevuto dalla cultura italiana nella misura in cui ha dato, sempre con generosità e senza fare calcoli (vizio che viceversa opprime molte menti brillanti del nostro Paese). Sarebbe giusto, a mio parere, restituirle qualcosa nella forma di un riconoscimento che merita abbondantemente.»
Roberto Pazzi, Verso Sant’Elena, Bompiani – proposto da Roberto Barbolini;
«Richiamandosi idealmente al suo folgorante esordio narrativo con Cercando l’imperatore, epica rievocazione degli ultimi giorni dello zar Nicola II, Pazzi focalizza qui il suo sguardo affabulante su un altro imperatore nel momento del declino: Napoleone prigioniero degli Inglesi sulla nave in rotta per Sant’Elena. E lo fa in maniera magistrale, mescolando romanzo storico e diario intimo, memento mori e fantasmagoria narrativa, con grande lucidità intellettuale e visionaria capacità di rivisitare momenti e figure della Storia. Nel tedio e nei malanni del viaggio, Napoleone rivive memorie e fantasmi della sua vita inimitabile: da Maria Luisa d’Austria a Metternich, da Talleyrand a maman Letizia Ramolino, da Paolina Borghese a papa Pio VII, una ridda di illustri ectoplasmi bussa alla porta della sua cabina. Sono figure nate dal ricordo, che come personaggi sfuggiti al loro autore via via prendono corpo e si trasformano in interlocutori in carne e ossa, rubandosi a vicenda il testimone in un’appassionata staffetta narrativa. «Non era finita, lui non credeva a quell’epilogo della sua storia, dopo Waterloo. Qualcosa di inaspettato sarebbe sopraggiunto»: nel condottiero sconfitto non si è spenta la sete di romanzesco che, giovanissimo, l’aveva spinto a tentare la strada delle lettere con il romanzo Clisson et Eugénie . E qui Pazzi ha l’intuizione davvero felice di resuscitare da quelle pagine giovanili il personaggio di Eugénie, come a dirci che la verità della letteratura sopravanza i clangori della Storia, dandocene la chiave di lettura più autentica e profonda. Eugénie che scrive sul quaderno di bordo è insieme l’appassionata deuteragonista di Napoleone scrittore mancato, e la controfigura narrativa dell’autore di Verso Sant’Elena. Nella Nuova enciclopedia Alberto Savinio osserva che «Napoleone diventò quello che tutti sanno, ma non riuscì a diventare quello che nel suo intimo desiderava: un letterato». Roberto Pazzi trasforma questo spunto in una profusa celebrazione di quell’indispensabile effetto-Sheherazade che fa della necessità di scrivere una questione di vita o di morte. Se neppure Napoleone riuscì a padroneggiare la Storia – è la sua riuscita scommessa – un vero scrittore può invece reinventarsi continuamente il destino padroneggiando una storia.»
Silvio Perrella, Io ho paura, Neri Pozza – proposto da Giorgio Amitrano;
«Io ho paura mostra la capacità dell’autore di esprimere e
analizzare un sentimento universale e connaturato all’uomo attraverso un
approccio personale e unico. Il suo punto di vista è quello di un
intellettuale che usa gli strumenti del pensiero e della cultura
nell’impossibile tentativo di controllare l’ignoto. La paura evocata da
Perrella è fisica e metafisica: emerge dai flutti del mare durante una
nuotata, si annida nel buio che si profila all’improvviso minacciando di
ingoiare l’esistente, o scaturisce da una minaccia alla propria
integrità fisica. Ma esiste anche una paura fabbricata artificialmente,
«globalizzata e pulviscolare», capace di esercitare una dittatura su
grande scala. Per Perrella la paura può essere analizzata, narrata ma
mai definitivamente esorcizzata perché elemento fondante della
sensibilità. La bellezza e il nitore della scrittura di Perrella nascono
anche dal misurarsi con la paura, che influenza e modella il suo
sentire. Il libro attinge con libertà e sapienza alle forme del romanzo e
del saggio senza optare per un genere in particolare, ma appartiene
chiaramente a una dimensione narrativa il cui tessuto poroso è capace di
assorbire citazioni letterarie, osservazioni critiche, riferimenti
artistici senza che essi interrompano mai il fluire di un racconto
raffinato e perturbante.»
Licia Pizzi, Piena di grazia, ad est dell’equatore – proposto da Francesco Durante;
«Si tratta di un breve, tesissimo racconto ambientato nelle profondità
di una remota campagna meridionale, al limitare di boschi infestati da
briganti e grotte governate da streghe. Ne è protagonista Grazia, una
femmina giovane, tozza e quadrata, quasi ferina, ceduta dalla madre e
dai fratelli come serva al macellaio del paese. Lì, contravvenendo alla
regola impostale dalla nonna, quella di “fare la brava” quasi per
combattere la sua natura ancestrale, Grazia fa veramente “la brava”, ma
al contrario: silenziosamente conformandosi sempre più a quella sua
natura selvatica. Non solo diventa la creatura più amata dai maiali del
macellaio, ma anche una specie di sciamana, un’assurda semidivinità
silvana, una “janara” cui attribuire la catena di disgrazie che
progressivamente si abbattono sulla famiglia del macellaio,
convincendola che sia necessario liberarsi di quella inquietante
presenza. Ma sarà tutt’altro che facile. Sostanzialmente il racconto
potrebbe definirsi un noir, ma è scritto come si potrebbe scrivere un
testo sperimentale, senza spreco di parole e con estremo rigore
stilistico. L’autrice – una beneventana che vive a Napoli – avrebbe
potuto cavare da questi materiali una specie di saga familiare
tradizionale, o magari un polpettone a tinte forti adatto al vasto
pubblico degli appassionati del genere; invece ha scelto questa via più
ardua, assolutamente letteraria, e secondo me ne è nato un piccolo
gioiello.»
Luca Ragagnin, Pontescuro, Miraggi Edizioni – proposto da Alessandro Barbero;
«Pontescuro di Luca Ragagnin è l’opera matura di un autore che ha
esplorato molte possibilità espressive della parola (canzone, poesia,
racconto, romanzo, saggio narrativo) in oltre trenta libri pubblicati,
senza contare le numerose collaborazioni musicali. Il romanzo si svolge
nel 1922, nella Bassa padana, nell’immaginario villaggio eponimo, e
analizza attraverso la testimonianza corale degli abitanti le premesse
di fatto di sangue: l’uccisione della bellissima e scandalosa figlia del
signorotto locale. Colpevole è il fattore, mosso da invidia sessuale e
sociale, ma dell’assassinio viene incolpato lo scemo del villaggio, un
trovatello che passa il tempo legando nastri colorati ai rami degli
alberi e che aveva stretto una tenera amicizia con la ragazza. Ciaccio,
il trovatello, è la personificazione dell’innocenza, allegoricamente
posta ai margini di una società che o sfrutta e opprime, oppure vive in
una tetra, stolida e quasi inconsapevole miseria materiale e morale (il
1922 è l’anno della marcia su Roma e nel romanzo riecheggiano le rivolte
contadine soffocate con manganelli e olio di ricino). Il romanzo, però,
non è indirizzato a una puntuale ricostruzione storica e sociale, ma si
interroga sul lato metafisico del male, nel duplice senso che può avere
l’espressione «il male che abita l’uomo»: oggettivo – il male in cui
l’uomo si adatta a vivere quotidianamente – e soggettivo – il male che
alberga, radicale, nel cuore umano. Il tema, certo ambizioso, è
avvicinato con riserbo e delicatezza. La presa di distanza si concreta
non solo nella distanza storica dell’epoca narrata rispetto all’oggi, ma
anche nella voluta neutralità linguistica – la lingua di Pontescuro
non è mai mimetica e non fa il verso al popolo o al periodo storico,
bensì è piana e astorica – e narrativa: la forma scelta si avvicina
molto a quella della favola, con ampio uso di prosopopee e cauti
simbolismi. Soprattutto quest’ultimo aspetto, quello favolistico, si
incarica di portare la riflessione dell’autore: affiancando il punto di
vista del narratore onnisciente a quelli di alcuni protagonisti (una
focalizzazione multipla che in quanto priva di rigore evita il rischio
di un’astratta metodicità), Ragagnin dà voce alla nebbia, al fiume, al
ponte, al cadavere della ragazza, a una ghiandaia, a una blatta; oltre
al narratore, sono quindi i testimoni innocenti o le vittime a prendere
la parola, a rispecchiare il male che alligna intorno a loro e contro di
loro. Allo stesso modo, nonostante l’introduzione di un ispettore di
polizia, sorta di anti-Ingravallo prossimo alla pensione, giunto da Roma
con scarso interesse per le beghe di provincia, i fatti materiali
relativi al delitto non prendono mai il sopravvento sulla riflessione
morale. L’arrivo dell’ispettore non rende centrali l’investigazione
sull’omicidio, il contesto sociale in cui questo matura, la congiura
contro il povero innocente e la sua fuga salvifica. L’ispettore, anzi,
occhio estraneo e acuto (anche la sua è una delle voci del romanzo), ha
un’altra, duplice, funzione: da un lato, riconoscere e avallare sia il
crimine sia il depistaggio, accettando la falsa ricostruzione che gli
viene proposta e che torna comoda a tutti, anche ai pigri funzionari
della capitale; dall’altro, soprattutto, raccogliere attorno al corpo
della vittima, nella chiesa del paese, i veri colpevoli della vicenda –
il fattore-assassino, il prete senza fede, il padre-padrone, la serva
invidiosa, degni rappresentanti del villaggio di Pontescuro – nel
momento preciso in cui una tempesta di uccelli suicidi si schianta
contro la chiesa, contro il campanile e le vetrate, inscenando un
olocausto di innocenti, un sacrificio volontario come riprova e sanzione
metafisica del carattere maligno, disperato, inaccettabile delle scelte
umane.»
Ghirghis Ramal, La colpa, DeA Planeta – proposto da Massimo Lugli;
«Il romanzo La Colpa, di Ghirghis Ramal, è un testo di rara
potenza e profondità di sguardo sulla realtà contemporanea, su quanto
sta accadendo in Occidente dove, a volte, le contraddizioni pubbliche e
quelle private rischiano di esplodere nel modo più doloroso e
scioccante. Ramal è un amante del vero, trae ispirazione da fatti
accaduti o che potrebbero accadere, con una rara potenza di
trasposizione letteraria in senso quasi ottocentesco. L’autore è il
primo a raccontare, dall’interno, la genesi di un attentato terroristico
messo a segno oggi, in Italia, da qualcuno che potrebbe essere il
nostro vicino di casa. Il maggior pregio del libro sta nella cura e
nella passione con cui l’autore entra nella testa dei personaggi, ne
descrive la psicologia e le motivazioni senza nulla togliere
all’insensatezza delle loro azioni e delle loro convinzioni. Molto
efficace la scelta di individuare le cause che li spingono a seminare
morte e terrore e di ribaltare diversi luoghi comuni sui conflitti
culturali e religiosi. Un romanzo, quindi, scomodo e coraggioso, che
descrive e fa parlare a personaggi di un mondo che non possiamo più
ignorare.»
Raffaella Romagnolo, Destino, Rizzoli – proposto da Giuseppe Patota;
«Destino di Raffaella Romagnolo racconta la storia di due donne
coraggiose, amiche e quasi sorelle, Giulia e Anita, tra il Piemonte di
inizio Novecento, l’America e il Piemonte ritrovato dopo le devastazioni
del fascismo e della guerra. Anche in questo nuovo, lungo racconto
l’autrice dà prova di grandi capacità nel descrivere i personaggi e nel
dar loro voce, attraverso una lingua credibile e ricca. Sottolineo che
non c’è niente che manchi alla lingua di questo romanzo. All’italiano
equilibrato e netto della voce narrante se ne associano altri; e a
questi italiani si aggiungono anche altre lingue. C’è l’italiano
ridondante delle autorità grandi e piccole e quello volenteroso del
maestro che avvia i suoi scolari all’italofonia; c’è l’italiano forbito
della buona società genovese e quello stentato ma dignitoso delle
operaie che in filanda rivendicano «il Giusto»; c’è l’italiano di Bandiera rossa
e quello della preghiera della buonanotte. C’è perfino, citato e
recitato a memoria, l’italiano altissimo di Dante; e poi ci sono il
dialetto del basso Piemonte, l’angloamericano balbettato dai nostri
emigrati, il francese di una giovane francese trapiantata negli Stati
Uniti. Nelle pieghe di queste varietà s’insinuano il turpiloquio
ossessivo di una madre e le bestemmie di un soldato, una più disperata
dell’altro. Sul piano generale dell’organizzazione del testo,
l’essenzialità della narrazione in terza persona si alterna, con ottima
orchestrazione, con la frammentarietà del discorso indiretto libero e
anche con la tensione verso una sintassi che, al momento opportuno, non
si vergogna di farsi più articolata. Destino di Raffaella
Romagnolo è quello che promette il suo sottotitolo: un romanzo che,
inserendosi in una grande tradizione, racconta Una storia italiana del Novecento.
La storia di due donne e di due destini, attraverso un’epopea familiare
appassionante, che trasporta il lettore da un paesino del basso
Piemonte a New York, e da qui di nuovo, nel 1946, nel Piemonte povero di
Borgo di Dentro. La storia di una migrazione, la storia di chi è
partito e la storia di chi è restato, raccontate con grande efficacia
narrativa.»
Carla Maria Russo, L’acquaiola, Piemme – proposto da Renata Pisu;
«In questo libro Carla Maria Russo abbandona il filone del romanzo
storico che le ha dato fama e consensi per affrontare una tematica dei
nostri tempi con personaggi che non vivono i grandi avvenimenti epocali
ma ne sono al massimo appena sfiorati come se i loro destini dovessero
compiersi in universi chiusi, così come è sempre stato per gli umili.
Qui siamo in tempi vicini ai nostri, una ancora povera Italia che tenta
di uscire dall’arretratezza, un nuovo ordine che si annuncia foriero di
cambiamenti e porterà a catastrofi delle quali non si indovinano nemmeno
i presagi, un paesino dell’Appennino meridionale dove la povertà ha
radici millenarie e la poca ricchezza permette al signorotto che la
possiede, soprusi che sanno di medioevo. Non c’è acqua corrente nemmeno
nella Casa Grande al centro dell’abitato dove abita con la famiglia don
Francesco che assolda Maria, appena quindicenne, a recarsi alla fonte
tre volte al giorno perché i padroni abbiano da bere, da cucinare, da
lavarsi. Maria accetta come se avesse ricevuto una benedizione dal
cielo, finalmente ha un lavoro, anche se pagato pochi centesimi, è
l’acquaiola della famiglia dei ricchi. È questa donna, un personaggio
inciso con tratti sapienti, che la narrazione segue negli anni, da
ragazza fino agli ultimi giorni della sua esistenza, silenziosa
testimone e giudice delle vicende di tutti gli altri. Dalla sua bocca
mai un lamento, mai una recriminazione, altera nella miseria, dura e
determinata, consapevole che la sua unica ricchezza sta nel rispetto di
sé e nella salvaguardia della propria dignità. Ma il suo destino
stranamente si intreccia con quello dell’ultimo figlio di don Francesco,
che da ragazza ha visto neonato e ritrova giovane ribelle, ansioso di
un futuro del quale intravede le potenzialità. Questo intreccio ha
conseguenze dolorose anche se possono rivelarsi alla fine come il
preludio di un possibile riscatto. Quando Maria, offesa e defraudata del
suo unico tesoro, non riesce a perdonare il male che le è stato fatto,
ecco che provoca altre dolorose conseguenze, come se dal male non
potesse nascere che il male. E invece la catena che a un’umanità umile e
legata alle tradizioni sembra non potersi mai interrompere, per Maria
si spezza e la donna giunta quasi alla fine dei suoi giorni realizza il
desiderio che ha sempre agognato: dare e ricevere amore. Sembrerebbe
incredibile un simile risultato a coronamento di una vita tanto arida e
dura dove il perdono, la prima forma dell’amore, è testardamente negato,
ma nel romanzo si esplora a fondo il delicato tema dei rapporti
familiari e specialmente la difficile relazione tra madre e figlia, tra
Maria e la sua figlia non voluta e la figlia di questa figlia. È stato
necessario subire un grande male, per far fiorire tanto bene, pensa la
vecchia Maria, un personaggio inconsueto e di certo indimenticabile
nella galleria delle eroine dei nostri tempi.»
Lodovica San Guedoro, Le memorie di una gatta, Felix Krull Editore – proposto da Pietro Gibellini;
«Una gatta che racconta le vicende letterarie della propria padrona,
mentre quasi in secondo piano, quasi in un controcanto/contrappunto,
racconta la storia della propria vita. Suggestivo il rovesciamento di
ruoli e punti di vista: non un umano che racconta la storia di un
animale, ma un animale che racconta la storia di un umano, un’umana, in
questo caso – e della corte dei miracoli che l’accompagna in questa
sorta di romanzo di formazione letteraria, leggero ed effervescente. Il
libro ha come nucleo narrativo le tragicomiche vicende che portano alla
pubblicazione del romanzo d’esordio della padroncina (chiamata
alternativamente anche mamma), che alla fine decide di reinventarsi
anche come editore, sobbarcandosi tutti i compiti più o meno ingrati che
all’editore incombono. Divertente e illuminante l’epos promozionale del
libro: presentazioni senza pubblico, manifesti pubblicitari strappati,
vane ricerche di protezioni letterarie in alto, burocrazie kafkiane, che
alla fine indurranno la padroncina-mamma-autrice-editrice a imboccare
malinconicamente e teatralmente la via dell’esilio in terra germanica,
auspice Thomas Mann e il capitano d’industria del suo ultimo romanzo,
Felix Krull, col cui nome la padroncina-mamma-autrice battezza la sua
fantasmatica casa editrice. Lungo l’odissea editoriale della donna
scorrono le tappe memorande della storia felina della gatta-autrice –
l’adozione, l’arrivo del fratellino, le due case nell’incanto della
terra toscana, l’uccisione del fratellino, la fuga (fortunatamente
provvisoria) dei padroncini, i viaggi e alla fine la sistemazione
definitiva. Il tutto narrato con grande garbo e con quella coloritura
profondamente femminile che accomuna fin dalle prime pagine l’autrice
narrata e l’autrice narrante. Al di là della trovata paradossale e
surreale – un felino scrivente – è facile intravedere nella
gatta-autrice il doppio dell’autrice-padroncina. Sdoppiamento che
permette a Lodovica San Guedoro di raccontare le proprie disavventure,
senza rispamiare una sorridente ferocia al bel mondo, alla cultura
consacrata, ai grandi editori, ai media onnipotenti»
Evelina Santangelo, Da un altro mondo, Einaudi – proposto da Helena Janeczek;
«Se fossi dietro una bancarella del mercato – cosa che non mi
dispiacerebbe – direi «venite, leggete questo romanzo che in neanche
duecentocinquanta pagine intreccia compiutamente quattro storie, anzi di
più: contiene uno, due mondi!» L’Italia, l’Europa, il nostro tempo così
difficile da raccontare, anche solo perché la frammentarietà delle
esistenze sembra rendere quasi impossibile afferrarne una porzione che
oltrepassi le mura di casa. Forse proprio per questo il nostro mondo è
così ossessionato Da un altro mondo che sbarca sulle nostre coste e si
adagia ai suoi margini in una dimensione parallela descritta da Zygmunt
Bauman con «vite di scarto». Ed eccole «le vite di scarto» di questo
romanzo. Il ragazzo Khaled, fuggito da una guerra in Medioriente, parte
dal cuore d’Europa, Bruxelles, con un trolley rosso per attraversare
un’Italia di capannoni abbandonati, fabbriche in nero, sotterranei.
Nella direzione opposta si muove il maresciallo Vitale a cui tocca
l’ingrato compito di indagare sul caso dei «Bambini Viventi», così
battezzati dall’isteria collettiva e mediatica, le cui prime inquietanti
apparizioni sono segnalate in una scuola del sud, a Palermo. Intanto,
una madre belga cerca il figlio scomparso un giorno qualsiasi in cui lei
svolgeva il proprio oscuro lavoro, puliva degli uffici nella capitale
politica d’Europa. Visto che poliziotti e magistrati vagano
nell’incertezza, arresi all’idea che possa essere stato risucchiato
dalla galassia jihadista o da quella neonazista, entrambe attivissime in
rete con parole d’ordine spaventosamente simili, Karolina non si dà per
vinta. Comincia a cercarlo ovunque, da sola. Infine c’è Orso, un
vecchio burbero solitario, che compie pure lui un «viaggio dell’eroe»,
anche se non si muove affatto dalla sua cascina al centro della pianura
padana emiliana, perché l’imprevedibile lo coglie inaspettatamente tra
le stesse mura di casa. Nel romanzo di Evelina Santangelo convivono
dunque personaggi reali e personaggi inafferrabili, ossia veri e propri
fantasmi. Una delle maggiori intuizioni del magistrale impianto sta
nell’aver ridotto i gradi di separazione tra gli uni e gli altri. Cos’è
un giovane neet finito chissà dove? Cosa diventa Karolina che perde
l’unica amica e il lavoro per cercarlo? O Khaled che rimpiange un
violento capocantiere chiamato «Padre Buono»? Cos’è il brutale Orso «di
nome e di fatto» che diventa una minaccia per la sua stessa comunità?
Questo è un romanzo che restituisce significato alle parole
«compassione» e persino «carità», ma «buonista» non lo è per nulla. Per
merito, innanzitutto, di una lingua tanto duttile quanto precisa,
screziata di toni colloquiali, a tratti violenta, come è il mondo che
esplora, mai tentata di schiacciare il pedale confortante del
sentimentalismo. È un libro coraggioso, perché oggi occorre coraggio a
voler conferire dignità agli «umili e offesi», vuoi che siano giunti da
un altro mondo vuoi che appartengano al nostro. Consapevole del rischio,
Evelina Santangelo cerca il sostegno dei maestri del racconto del reale
e del fantastico – da Sciascia a Stephen King a Morante e altri ancora.
Solo la letteratura, d’altronde, è in grado di rendere paure, desideri e
tutto ciò che – pur invisibile – guida le nostre vite altrettanto reali
del teatro in cui le vite stesse si svolgono. L’ultimo motivo per
essere grati a questo libro è ritenerlo un’opera letteraria capace di
reinventare le proprie possibilità e il proprio compito.»
Antonio Scurati, M. Il figlio del secolo, Bompiani – proposto da Francesco Piccolo;
«Scurati racconta con dedizione e ostinazione la nascita del fascismo in Italia, non tralasciando nessun dettaglio decisivo alla comprensione della nostra Storia, attenendosi ai fatti documentati e appassionando i lettori per pagine e pagine, come hanno dimostrato le reazioni fin dal primo giorno della sua comparsa nelle librerie. Il racconto corale, con al centro la figura di Benito Mussolini, compie il miracolo di farci comprendere come i fatti prendano consistenza e poi potenza in pochi anni, con la complicità dell’indifferenza e della superficialità di un intero popolo. Nonostante quest’anno tra i candidati al premio Strega siano presenti libri e autori che apprezzo, propongo M. di Antonio Scurati perché è un evento nella letteratura italiana, uno dei romanzi importanti dei nostri anni, che merita per questo non solo di partecipare al Premio Strega ma di vincerlo.»
Piero Sorrentino, Un cuore tuo malgrado, Mondadori – proposto da Diego De Silva;
«Un cuore tuo malgrado, romanzo d’esordio di Piero Sorrentino, è
un’opera prima dalla scrittura sapientemente misurata nel trattare un
tema delicato e indigesto come il senso di colpa. Sarebbe stato tutto
sommato facile, per un autore napoletano di talento, saccheggiare la sua
conoscenza ventrale della città per costruire un romanzo che
incontrasse con ragionevole prevedibilità i gusti di un pubblico
bendisposto a storie diversamente folk. Sorrentino ha accettato una
sfida narrativa ben più difficile, e a mio parere l’ha già vinta.»
Paolo Teobaldi, Arenaria, Edizioni E/O – proposto da Domenico Starnone;
«È la più recente creazione di uno scrittore straordinario, definizione
questa che potrà sembrare eccessiva solo a chi non abbia letto almeno
una delle sue opere: Scala di Giocca, Finte, La discarica, Il padre dei nomi, La badante, Il mio manicomio, Macadàm,
libri appunto fuori dell’ordinario. Teobaldi è nato a Pesaro, è vissuto
quasi sempre a Pesaro e il mondo al quale ha dato una forma letteraria
memorabile ha fondamenta solidissime in quella città e nel suo
territorio. Arenaria è un tassello molto importante di questa
costruzione pluridecennale, abilissima e insieme appassionata. A
raccontare è un nonno benemerito che sa tutto ma proprio tutto
sull’altura d’arenaria – altura modesta: 200 metri sul livello del mare
il punto più alto – in cui ci si imbatte scendendo dalla pianura padana
lungo l’Adriatico, prima del monte Conero. Il racconto è costruito
apposta per la nipotina Julie, bimba di pochi mesi, poi di pochissimi
anni, francesina anglo-italiana di nascita, e con una vita futura pronta
ad accogliere chissà quante lingue. In poche pagine il nonno si tira
dietro la nipote per l’intero Novecento tenendosi sempre, saldamente, a
piccole-grandi storie di avi e parenti e amici miserabili, tutte da
ridere e che però, se le smuovi un po’, vengono le lacrime. In
superficie la scrittura è quella che mima il parlato: il nonno infatti è
un grandissimo narratore orale e noi lettori pendiamo dalle sue labbra
ancor più di Julie. Ma attenzione: la mimesi di Teobaldi è attentissima
alle parole degli altri, la sua voce (come quella del personaggio) è
fatta con materiali di provenienza molto varia, stracolti e di scarsa
alfabetizzazione (bisogna soffermarsi sulle pagine che raccontano la
pesca alla tratta, un po’ perché sintetizza bene la forza della
scrittura di Teobaldi, un po’ perché pare una metafora efficace della
sua fatica di scrittore). Insomma Arenaria abbaglia. Ci fa
riscoprire cosa si può fare con la nostra ricchissima lingua, se non ci
abbandoniamo mai per pigrizia a un pugno di paroline e parolacce
abusate, se non ci dimentichiamo il piacere di raccontare. Il risultato è
un gioiello lavoratissimo che ci consegna, in perfetto equilibrio,
memorie locali di esistenze logorate dalla miseria, e il racconto –
realizzato con gli strumenti più fini (l’ironia innanzitutto) della
grande letteratura – di come tutto poggi sulla sabbia e facilmente
frani, innanzitutto le parole della vita grama.»
Nadia Terranova, Addio fantasmi, Einaudi – proposto da Pierluigi Battista;
«In questo romanzo emozionante e profondo Nadia Terranova, come Telemaco
alla ricerca del padre Odisseo, torna nella sua città natale e nella
casa messinese della sua infanzia alla ricerca di tracce della figura
paterna che si è come volatilizzata, rendendosi assente al mondo ma non
nella memoria della protagonista. Il padre è scomparso: con ogni
probabilità è morto tanti anni prima, ma il suo corpo non è mai stato
trovato. E non c’è funerale possibile per un morto che forse non è
morto. Mentre Telemaco parte da Itaca per conoscere il destino del
padre, Nadia Terranova torna a Itaca-Messina perché attraverso gli
oggetti della sua infanzia, gli odori e i colori della sua città,
l’atmosfera della casa che la madre ha deciso di mettere in vendita, può
finalmente fare i conti con se stessa e con il fantasma di un padre che
non c’è più. E mettere a punto, nel tratto di mare che separa Scilla e
Cariddi, la cerimonia degli addii indispensabile per continuare a vivere
dopo aver portato a termine il lutto.»
Veronica Tommasini, Mazzarrona, Miraggi Edizioni – proposto da Giovanni Pacchiano;
«Nel romanzo di Veronica Tomassini, Mazzarrona, diversamente
dall’attuale pullulare di una letteratura d’evasione, l’autrice racconta
sul filo del ricordo, con nobile e profonda passione, governata
peraltro da un sapiente controllo della scrittura, le vicende,
ambientate nell’estrema e degradata periferia di Siracusa (una realtà di
falansteri e baracche ed amianto), di un mondo di giovani emarginati e
drogati con poca o nessuna speranza di sopravvivere. La sua
protagonista, una ragazza piccolo-borghese estranea a quel mondo ma
insieme emotivamente coinvolta, cerca lì invano un affetto e un amore
stabili, ma il ricordo di quei momenti di candore e di strazio è
destinato a rimanere per sempre.»
Michele Vaccari, Un marito, Rizzoli – proposto da Marcello Fois;
«Un marito di Michele Vaccari è un romanzo che ha a che fare con
la tradizione alta della narrativa italiana del dopoguerra. Scrittura
muscolare, qualche volta muscolosa, per iniziare e secchezza neorealista
per finire. C’è tutto l’armamentario di quanto da Manzoni in poi
abbiamo imparato a definire italico. La passione per i personaggi
semplici innanzitutto, quelli come Patrizia e Ferdinando, talmente fuori
dal proprio tempo e dalle sue malìe da sembrare dei piccoli marziani
descritti da Zavattini. Poi l’idea che esistono persone per cui guardare
oltre può significare dare un’occhiata alla bocca incandescente
dell’inferno un po’ come accade a Pietro Catte ne Il giorno del giudizio
di Salvatore Satta. Quindi la constatazione che il tempo della
solitudine è di un’amarezza persino amabile esattamente come certe
intermittenze del cuore nei personaggi di Svevo o certi rapidissimi
abissi esistenziali dei giovani mariti di Pratolini o, ancora, nel
disincanto silenzioso, ma non per questo pacificato, dei soldati
asserragliati nella Fortezza Bastiani di Buzzati. Un marito è
dunque, fin dal titolo, un piccolo compendio del ruolo maschile in
questa commedia/tragedia infinita e infinitamente narrabile che è la
coppia. E rappresenta una specie di esito finale nella produzione ampia,
e sotto molti aspetti da riscoprire, dell’autore genovese. In assoluto
l’esito più intimista che questo interessante scrittore abbia raggiunto
dopo romanzi come Italian fiction, L’onnipotente, Il tuo nemico.
Tutte prove che intraprendevano un percorso solidamente legato
all’impegno civile con qualche virata di giovanile moralismo. Il quale
nel caso di Vaccari è un peccato veramente veniale perché vissuto con
una sincerità ai confini dell’autolesionismo. Ora questo meccanismo che è
spesso letale, se non demotivante, nei grandi fatti e nella espansione
dei massimi sistemi politici o sociali, funziona alla perfezione in Un marito
che è una storia minima di coppia senza qualità; la vicenda di un
Ferdinando (Tramaglino) e di una Patrizia (Mondella) senza che nessun
Don Abbondio gli abbia impedito a suo tempo di conoscersi, apprezzarsi,
amarsi, sposarsi, aprire un piccola azienda a conduzione famigliare. E
tutto questo senza quasi mai uscire da quel microcosmo magmatico e a sé
stante che, dentro Genova, è il quartiere di Marassi. Qui davvero
parrebbe in tutto valida quella celeberrima indicazione tolstoiana a
proposito del fatto che l’unica strada per ottenere un impatto
universale e quella di partire dal proprio vissuto, dal proprio cortile,
dal proprio quartiere. Perché lo spostamento dentro l’esperienza
sentimentale e l’elaborazione di un giovane uomo sembrano aver
consolidato tutto quanto nella scrittura di Vaccari pareva in fieri,
quasi che attingendo alla propria intimità, e al proprio cortile,
l’autore sia riuscito a raggiungere quella sintesi tra la scrittura
d’impegno civile e la narrazione di sentimenti che, da tempo, andava
cercando. Un marito racconta di Ferdinando e Patrizia che, dopo
anni di sacrifici, e dopo anni di turni massacranti al loro forno
popolare nel quartiere dove abitano da sempre, decidono di prendersi una
vacanza nell’esotica Milano. Ma non lasciatevi ingannare, è possibile
che in questi novelli Candidi vi sia ancora un frammento della struggente
ingenuità con cui anche Totò e Peppino, ere geologiche prima, avevano
affrontato lo stesso viaggio, ma i tempi sono impietosamente cambiati.»



















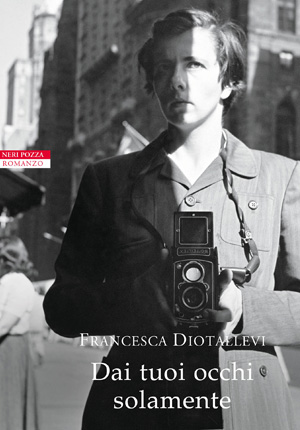



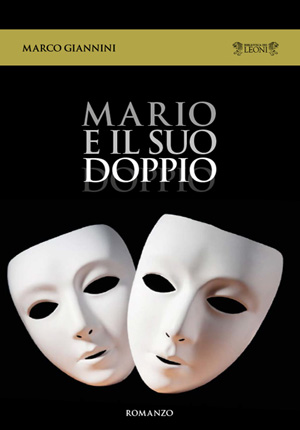


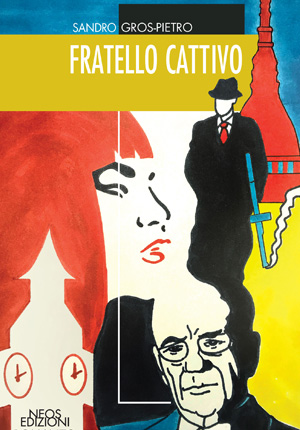

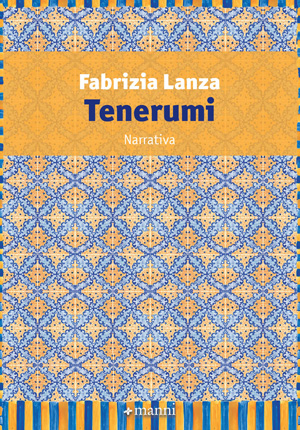



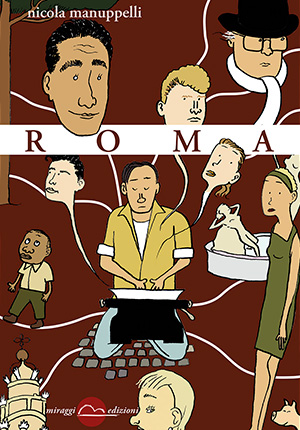





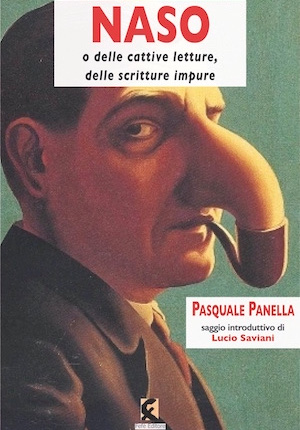

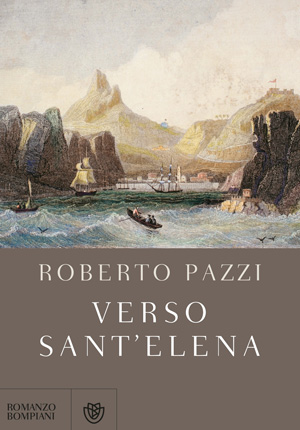

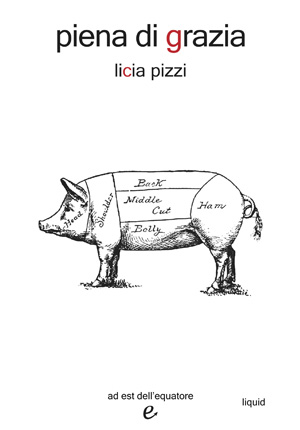
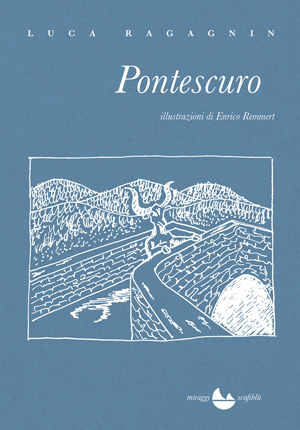

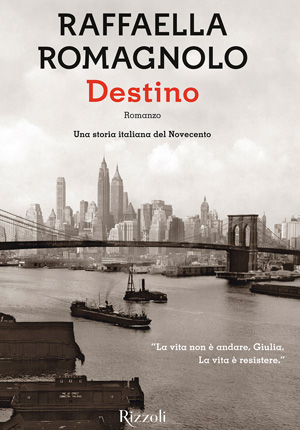
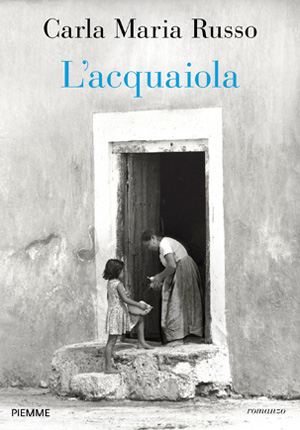




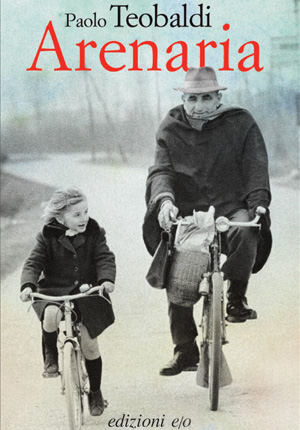



Nessun commento:
Posta un commento